
Tempo
Le ore scorrono veloci verso la fine di un anno ma la densa nebbia di dicembre pone l’accento sulla stasi. È un momento di transizione, eppure in queste giornate in cui la campagna è ferma non riesco a smuovere le mie emozioni dal sentimento della perdita. Di cosa? Dei momenti memorabili che sono andati e che ho vissuto con tutta me stessa e conservo nella memoria o hanno costruito pezzi di me e dei miei sogni, ma fanno parte ormai di un passato che ha creato cause nella mia vita di oggi ma che è ormai andato, immodificabile? Il bianco ovattato del cielo di stamattina ha reso il ricordo di un sogno vivido e attraente, quasi volesse fermarmi nel sonno, dove la mia immaginazione non ha limiti e la vita può ripercorrere strade abbandonate o inventarne di nuove, oppure può ripetersi uguale con piccole variazioni di senso.
Sognavo di un pianista di Tel Aviv che veniva a suonare in una sala concerti così piena da non poter quasi respirare. Era un vecchio signore che prima di iniziare il concerto si attardava sulla tastiera per cercare di risolvere un problema tecnico del suono e questo creava un inizio di incendio sotto la coda del Grand Piano. Nonostante l’incidente, la confusione per spegnere il fuoco e la fuga di molti spettatori, lui si prestava a eseguire un concerto memorabile in trio con un violinista e un violoncellista. Credo che suonassero un trio di Bedrich Smetana, ma non ricordavo la musica al risveglio, solo la mia commozione per aver potuto assistere dal vivo a un evento irripetibile. Infatti eravamo rimasti in pochi ad ascoltare, pochi e vicinissimi ai musicisti, tanto da abbracciarli alla fine e condividere con loro le lacrime dell’emozione.
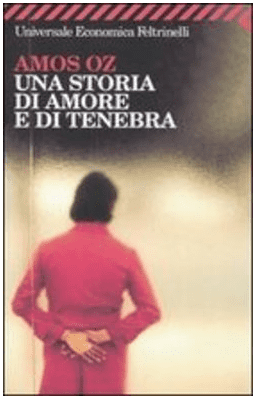
Ieri è morto Amos Oz a Tel Aviv e credo che la sua scrittura sia voluta entrare nei miei sogni per ricordarmi di ricordarlo, per riportarmi alle sue parole che ho amato mentre le rendevo parte della mia vita leggendole. L’autobiografia dal titolo “Una storia di amore e di tenebra” (Feltrinelli Editore) mi ha accompagnata per mesi all’inizio del 2018 e mi ha aiutata ad attraversare un anno di grande trasformazione, nel quale ho voluto concentrare molto della mia intenzione sulla ricerca nella scrittura, ancora più che negli anni precedenti.
“Scrivere un romanzo”, scrive Amos Oz, “è più o meno come montare con i mattoncini del Lego tutte le catene montuose d’Europa. O costruire un’intera Parigi, case piazze viali torri sobborghi, sino all’ultima panchina di un parco, usando solo fiammiferi e mezzi fiammiferi. Per scrivere un romanzo di ottantamila parole bisogna prendere, cammin facendo, circa un quarto di milione di decisioni: non solo sull’andamento dell’intreccio, su chi vivrà e chi morirà, chi amerà e chi tradirà e chi diventerà ricco o andrà in rovina e sui nomi dei personaggi e le loro facce e le loro abitudini e il loro mestiere, e su come suddividere in capitoli, e sul titolo del libro (sono le decisioni facili da prendere, quelle categoriche); non solo quando dire e quando occultare e che cosa viene prima e che cosa viene dopo e che cosa svelare fin nei dettagli e che cosa solo per allusione (anche queste sono decisioni semplici). Bisogna soprattutto prendere miriadi di decisioni sottili, come ad esempio se mettere lì, nella terza frase verso la fine del brano, blu o celeste? O azzurro? O magari celeste scuro? O azzurro cenere? E questo azzurro cenere, poi, va scritto già all’inizio della frase? O non è meglio spanderlo solo alla fine della frase? O in mezzo? O lasciarlo invece come una frase brevissima a sé stante, un punto davanti e un punto e una nuova riga dietro? O no, forse è meglio che questo colore sia intinto nella corrente di una frase lunga e composita, articolata e fitta di termini? Forse invece conviene proprio scrivere in quel punto solo tre parole, “luce della sera”, senza tingere quella luce della sera di alcun grigio celeste o azzurro cenere?”
All’inizio del 2018 mi ero riproposta di affrontare un romanzo e a più riprese ci ho provato, ma mi sono sempre arenata. I tentativi mi hanno spinto a esplorare tante strade diverse, ad accumulare pagine e pagine di storie a volte collegate a volte spaiate, ad andare avanti nonostante la difficoltà di prendere le decisioni di volta in volta, e più spesso ad andare avanti a prescindere dalle decisioni disperdendomi con la scrittura, un po’ come faccio nella vita. Non sono arrivata alla fine, se non di qualche racconto, ma posso darmi atto di aver rispettato una disciplina autoimposta nello scrivere, che avevo abbandonato negli anni dedicati ai bambini ancora piccoli e a un lavoro totalizzante come quello di costruire un agriturismo, e dalla quale oggi non riesco ad allontanarmi se non stando male.
Nonostante l’impegno e la gratificazione personale che ne deriva, spesso mi capita di sentirmi intrappolata in un flusso temporale che vorrei fermare per scrivere. Oggi però mi domandavo: Scrivo invece per fermare il tempo che mi rincorre? È questo che mi blocca, che non mi permette di arrivare a una fine? È l’impossibilità intrinseca all’impresa quello che devo affrontare e attraversare? Sono domande nuove alle quali non so dare risposta ma che sono emerse leggendo una poesia che ha toccato in questi giorni un punto dolente del mio sentire.
Scrive Wisława Szymborska, in Gente sul Ponte:

Strano pianeta e strana la gente che lo abita.
Sottostanno al tempo, ma non vogliono accettarlo.
Hanno modi per esprimere la loro protesta.
Fanno quadretti, ad esempio questo:
A un primo sguardo nulla di particolare.
Si vede uno specchio d’acqua.
Si vede una delle sue sponde.
Si vede una barchetta che s’affatica.
Si vede un ponte sull’acqua e gente sul ponte.
La gente affretta visibilmente il passo
perché da una nuvola scura la pioggia
ha appena cominciato a scrosciare.
Il fatto è che poi non accade nulla.
La nuvola non muta colore né forma.
La pioggia né aumenta né smette.
La barchetta naviga immobile.
La gente sul ponte corre proprio
là dov’era un attimo prima.
È difficile esimersi qui da un commento.
Il quadretto non è affatto innocente.
Qui il tempo è stato fermato.
Non si è più tenuto conto delle sue leggi.
Lo si è privato dell’influsso sul corso degli eventi.
Lo si è ignorato e offeso.
A causa d’un ribelle,
un tale Hiroshige Utagawa
(un essere che del resto
da un pezzo, e come è giusto, è scomparso),
il tempo è inciampato e caduto.
Forse non è che una burla innocua,
uno scherzo della portata di solo qualche galassia,
tuttavia a ogni buon conto
aggiungiamo quanto segue:
Qui è bon ton
apprezzare molto questo quadretto,
ammirarlo e commuoversene da generazioni.
Per alcuni non basta neanche questo.
Sentono perfino il fruscio della pioggia,
sentono il freddo delle gocce sul collo e sul dorso,
guardano il ponte e la gente
come se là vedessero se stessi,
in quella stessa corsa che non finisce mai
per una strada senza fine, sempre da percorrere,
e credono nella loro arroganza
che sia davvero così.
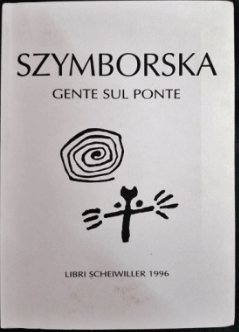
Avevo iniziato il 2018 in compagnia di Carlo Rovelli e il suo “L’ordine del tempo” (Adelphi Edizioni) che mi ha ancorata al suo epilogo di una trattazione sulle frontiere della fisica rispetto alla nostra percezione del tempo che metteva in luce le risonanze con il buddismo: “Buddha lo ha riassunto in poche formule, che milioni di uomini hanno preso a fondamento della propria vita: la nascita è dolore, la decadenza è dolore, la malattia è dolore, la morte è dolore, l’unione con ciò che odiamo è dolore, la separazione da ciò che amiamo è dolore, non ottenere quello che desideriamo è dolore. È dolore perché quello che abbiamo e a cui ci attacchiamo poi lo perdiamo. Perché tutto quello che inizia poi finisce. Quello che soffriamo non è né nel passato né nel futuro: è lì ora, nella nostra memoria, nelle nostre anticipazioni. Aneliamo all’atemporalità, soffriamo il passaggio; soffriamo il tempo. Il tempo è il dolore. Questo è il tempo, e per questo ci affascina e ci inquieta, e forse anche per questo, lettore, fratello, hai preso in mano questo libro. Perché non è altro che una labile struttura del mondo, una fluttuazione effimera nell’accadere del mondo, ciò che ha la caratteristica di dare origine a quello che noi siamo: esseri fatti di tempo. A farci essere, a regalarci il dono prezioso della nostra stessa esistenza, a permetterci di creare quell’illusione fugace di permanenza che è la radice di ogni nostro soffrire.”

Il tempo, le stagioni, la memoria, sono parole che hanno illuminato le mie letture di questo anno, a cominciare proprio dal romanzo magnifico di Amos Oz che, raccontando una vita intera, la sua vita di scrittore, dalle generazioni che lo hanno preceduto, ai suoi ricordi d’infanzia, ai momenti fondamento di tutta la sua scrittura, è intrinseco di temi che riguardano il tempo e la memoria, il tempo e la scrittura, la scrittura nello scorrere del tempo, la scrittura e il potere di far rivivere un tempo o di fermare il tempo. Ritorno al mio mondo dei sogni stasera, pensando a un’immagine regalatami da Amos Oz, che mi attanaglia e mi consola e che vive al di là della sua morte che mi trovo oggi a piangere: “Tu, questa sera non la dimenticherai mai: non hai che sei, forse nemmeno sei anni e mezzo ma per la prima volta nella tua piccola vita ti si è aperto qualcosa di immenso e tremendo, qualcosa di grave e di severo, qualcosa che si apre all’infinito sino all’infinito e viene su di te ed è immenso muto e penetra e ti spacca tutto d’un tratto, ti spacca in modo che anche tu per un momento sei come più largo e profondo di te stesso e con una voce che non è la tua ma forse è proprio la tua che avrai fra trenta, quarant’anni, una voce imperativa e categorica che ti comanda di non dimenticare mai nulla di questa sera: ricorda e serba questi odori, ricordane il corpo e la luce, ricorda gli uccellini le note del pianoforte le grida dei passanti e tutte le sfumature di cielo cangiante sotto i tuoi occhi da un orizzonte all’altro e tutto per te, tutto solo per gli occhi di chi osserva. E non dimenticare Danush e Ammi e Lulik e le ragazze con i soldati nel boschetto e nemmeno quel che disse tua nonna all’altra nonna né il pesce dolce che galleggiava, morto e condito, dentro la gelatina di carota. Non dimenticare il granello ruvido di ghiaia bagnato che ormai più di mezzo secolo è trascorso da quando l’avevi in bocca eppure l’eco del suo sapore grigio sapore di gesso e un po’ calce e un po’ sale ancora ti urla sulla punta della lingua. E tutti i pensieri di quella pietra, non dimenticare, un universo dentro un universo dentro un universo. Ricorda, la vertigine del tempo dentro il tempo dentro il tempo e la volta del cielo che misura mischia intacca il bottino di colori di luce appena dopo che il sole è tramontato, amaranto e celeste e cedro arancione oro luce pura porpora e scarlatto e vermiglio e celeste e oro e rubino col sangue che sgorga e su tutto scende lento lento un blu grigio opaco e profondo che ha il colore del silenzio e il profumo di note di un pianoforte che invano ripete e ripete in rampicata incerta su una scala rotta, e una capinera che gli risponde con le prime cinque note di Per Elisa: Ti da da da da.”
E ancora: “Cinquantacinque anni dopo, seduto a scrivere di quella sera sul quaderno al mio tavolo da giardino di Arad, ecco che torna quella brezza della sera e dalla finestra dei vicini anche qui, anche stasera esce una scia giallastra di luce densa e pigra come vischio lubrificante, la conosco, da quanto tempo la conosco, non mi stupisce più. Però, la sera della pietra in bocca in cortile a Gerusalemme non è certo arrivata sino ad Arad per scacciare l’oblio né per smania di nostalgia, al contrario: quella sera scende ad aggredire questa. Un po’ come una donna conosciuta tanto tempo prima, che ormai non fa più né caldo né freddo, che quando ci si incontra ha più o meno sempre le solite cose da dirti e quando ci si incontra ti sfodera un sorriso tutt’al più una pacca di circostanza sul petto ma questa volta come mai no, questa volta no, di colpo invece allunga la mano e ti tocca e ti prende per la camicia ma non per scherzo, no si aggrappa a te con grazia e disperazione gli occhi chiusi una smorfia di dolore sul viso che insiste vuole deve e non cede e ormai non le importa più di te e che cosa provi quello che vuoi quello che non vuoi non le importa adesso lei deve lei non ce la fa più adesso lancia e ti arpiona e comincia a tirare e tira e ti strappa ma poi non è lei che tira, lei solo pianta le unghie invece sei tu che tiri e scrivi tiri e scrivi come un delfino con l’arpione conficcato nella carne ora tira più forte che può per scappare e tira e tira dietro a sé più forte che può l’arpione e la corda legata all’arpione e tira anche il cannone legato alla corde e tira anche la barca dei suoi cacciatori con il cannone, tira e nuota tira per fuggire tira e si gira nell’acqua, tira e s’immerge nell’abisso nero, tira e scrive e tira ancora, se tira ancora una sola volta più forte che può magari si arrendono e liberano quello che ha conficcato nella carne, che morde e buca e non cede, tu vai e tira e quello solo morde, tira ancora e quello si conficca sempre più e prova se riesci a rendere pari dolore di questa disgrazia sempre più fonda e lancinante perché lui è l’aggressore e tu l’aggredito, lui è l’arpione e tu il delfino lui dà e tu hai preso lui la sera che fu allora a Gerusalemme e tu nella sera qui adesso ad Arad. Lui i tuoi genitori morti e tu tira tira e tira e scrivi.” Se c’è una cosa che ho imparato in questo 2018, grazie alla scrittrice Rossana Campo e ai suoi laboratori sulla scrittura autobiografica, è che scrivere è scavare dentro di sé e scavare è questo tirare di cui parla Amos Oz. Non è un compito leggero, facile, richiede forza e coraggio, richiede la promessa a se stessi di puntare al vero, di non fermarsi in superficie, di calare tutte le maschere e mostrarsi per chi si è veramente, anche se può far male, anche se da questo mostrarsi non si torna indietro.
