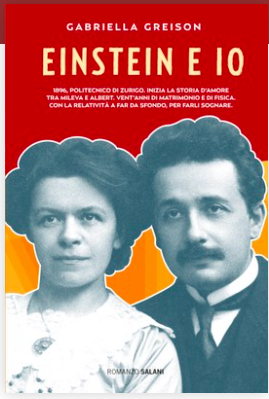
Primo
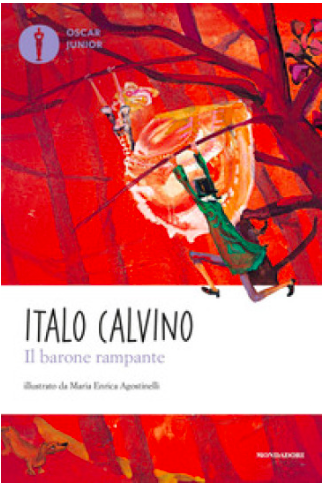
Nella Nuvola di Fuksas, in occasione di Plpl2018 mi è capitato di rivedere il primo amore. E da allora oscillo tra le parole primo e ultimo riferite all’amore. Non abbiamo sempre la fortuna di riabbracciare la persona con la quale abbiamo sperimentato l’innamoramento per la prima volta, il rapporto d’amore, la sua parabola e, succede, la sua evoluzione verso una fine. E cosa resta allora? All’inizio solo lo strappo, la ferita, poi il tempo la guarisce, rimane una forma di amore per quello che eravamo, che siamo stati insieme. Avevo diciotto anni, forse ero già grande per l’esperienza del primo bacio, ma se mi rivedo oggi ero così giovane e, prima di quell’incontro, di quel bacio, avevo uno sguardo sul maschile che era innamorato nella fantasia ma mai nella realtà. Riempivo pagine di diari su chi mi piaceva, il mio compagno di liceo che ammiravo a distanza, qualche nuovo incontro che mi incuriosiva per uno, due, tre giorni, qualche mese e non di più, perché presto un’altra persona stimolava le mie fantasticherie ancora adolescenziali. Loro non ne sapevano nulla, un amico appena conosciuto, un compagno di studi, di scuola, di università, di una vacanza, ragazzi che sfioravano la mia vita in un modo o nell’altro.
Poi è arrivato lui, tra i banchi di Fisica a “La Sapienza”, le conversazioni rapite dai problemi di analisi da risolvere, dai piani inclinati, dai giroscopi, i pranzi alla mensa di Via de Lollis. Io più che altro ascoltavo e guardavo, non parlavo molto, ero incantata. E così, galeotto, arrivò un bacio perugina che lui mi mise in mano dopo l’orale di Geometria I, uno degli esami del primo anno, superato insieme, tutti attorno a sostenerci e lui che mi sorprende con un dono segreto. Ci prendiamo la mano per uscire dall’edificio e non molliamo quell’aggancio di dita, fino al primo bacio. Che arriva alla fine di una giornata in mezzo a tutti gli amici in festa, noi in una bolla con quelle mani unite.
Succede però, dopo quell’incontro di labbra, che io perdo del tutto la facoltà di parlare, non con tutti, solo con lui, tanto che, passata qualche settimana di passeggiate in cui lui parla e io ascolto, mi dice: “ma tu non parli mai?”. E quella domanda rimane per entrambi senza risposta. Le mani si sciolgono per un po’ mentre io ritrovo le parole, passo dopo passo, comincio a uscire allo scoperto raccontando quello che provo, che penso, diventiamo amici e le nostre mani si ritrovano per “conoscersi e riconoscersi”, nel senso che ritrovo ne “Il Barone Rampante” di Italo Calvino (Oscar Mondadori); “Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in realtà non s’era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché, pur essendosi saputa sempre, mai s’era potuta riconoscere così”.
Diventiamo inseparabili, così diversi eppure così simili, complementari, inseguiamo la conoscenza del mondo fisico, delle leggi dei fenomeni, ci passiamo libri che parlano di scienza e di vita, Einstein, Feynman, Fermi, Schrodinger, Hofstater, i grandi fisici e filosofi, gli scrittori illuminati. Ci vediamo ogni giorno o quasi, eppure ci scambiamo lettere, perché la parola scritta arriva e rimane e le lettere d’amore sono doni a prescindere. Siamo due per uno, uno per due, due per una, una per due. Finché qualcosa in noi comincia a cambiare, la conoscenza di noi due non è abbastanza, il tutto diventa niente e non è sufficiente a lui né forse a me, anche se è lui ad accorgersene per primo, ad avere il coraggio di lasciarmi su Viale del Policlinico, di fronte a un ospedale: “Non posso più essere me stesso in questo rapporto, capire chi sono, cosa voglio, so solo che sto male”, mi dice. Non c’è un’altra, di quello sono certa, come so nel mio intimo che la sua decisione vede anche il mio star male, lo sente. Eppure è doloroso, lacerante, per entrambi. Ci metto anni a perdonare, provare gratitudine per quel momento, quello strappo netto, irreversibile ma delicato, e sentire quanto fosse stato necessario. Ognuno prosegue il suo viaggio, ci perdiamo di vista.

Diventiamo credo “amici stellari”, un’espressione che Eugenio Borgna riprende da Nietzsche, nel suo “Le parole che ci salvano”: “Noi siamo due navi, ognuna delle quali ha la sua meta e la sua strada; possiamo benissimo incrociarci e celebrare una festa tra di noi, come abbiamo fatto: allora i due bravi vascelli se ne stavano così placidamente all’ancora in uno stesso porto e sotto uno stesso sole, che avevano tutta l’aria di essere già alla meta, una meta che era la stessa per tutti e due. Ma proprio allora l’onnipossente violenza del nostro compito ci spinse di nuovo l’uno lontano dall’altro, in diversi mari e zone di sole e forse non ci rivedremo mai – forse potrà anche darsi che ci si veda, ma senza riconoscerci: i diversi mari e soli ci hanno mutati! Che dovessimo divenire estranei è la legge incombente su noi: ma appunto per questo dobbiamo diventare più degni di noi! (…) Ma la nostra vita è troppo breve, troppo scarsa la nostra facoltà visiva per poter essere più che degli amici nel senso di quella nobile possibilità. E così vogliamo credere alla nostra amicizia stellare, anche se dovessimo essere terrestri nemici l’un dell’altro”.
“L’amicizia ha in sé il significato di un dialogo infinito che continua anche quando non ci si vede, non ci si incontra e non ci si parla. Quando ci si rivede con una persona amica, si cancella il silenzio e si rimuove l’assenza: si ricostituisce il dialogo solo apparentemente perduto ma, in realtà mai interrotto. Il tempo, il tempo interiore non si slabbra, e nemmeno si incrina, e il linguaggio del silenzio ritorna a essere il linguaggio della parola: il linguaggio dei volti che si riflette negli occhi e negli sguardi”.
Così io intuisco qualcosa di lui, ogni tanto, nello scorrere del tempo. So che ha realizzato tanti sogni, grazie al suo cuore aperto e alla sua mente brillante e generosa, destinata a creare una vita di valore. Lo ritrovo dopo molti anni, nell’editoria, fisico perduto anche lui ma non troppo distante dall’intento iniziale. Lo ascolto parlare, provando quella gioia legata alla coerenza dell’essere umani. Ritrovo in lui quella luce, quel fervore, quel bisogno di confrontarsi con problemi difficili.
Da parte mia: “Ho una vita complicata”, gli racconto, “mi sono allontanata dalla fisica, dalla ricerca, per scrivere di scienza. Poi la scrittura mi ha portata oltre e mi sono messa in testa che avrei trovato la mia voce nell’inglese che non conoscevo abbastanza bene e sono emigrata in America, e poi e poi…”
Lui mi ferma e mi dice: “Sai, avevo una prof di matematica al liceo che mi diceva, ‘tu se hai una cosa davanti non scegli la strada più diretta, prendi una curva e ci arrivi in modo tutto tuo, ti piace complicarti la vita’. È un po’ così per noi, non trovi?”
Arrivare alle soluzioni facili è banale in fondo. E io, che mi sono sempre sentita una in fuga, ascolto le sue parole che illuminano anche me perché forse è ciò che è ovvio a non essermi mai bastato, devo andare oltre, arrivarci da chissà quale sentiero contorto, dal punto di vista che, perdendomi, riesco a ritrovare. È così che ritrovo ciò che rimane nell’ombra. Ascoltandolo, oggi come allora, rivedo nel presente la persona di un tempo. La sua mente ha immagazzinato conoscenza, è evoluta, ma il cuore è rimasto intero, l’intento, la missione era quella ed è rimasta tale: capire e far capire, condividere la conoscenza.
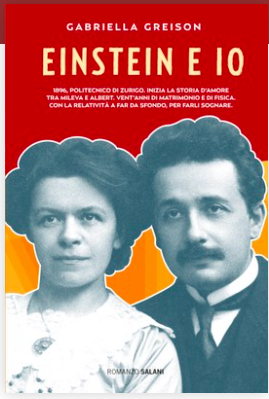
Pochi giorni fa ho finito di leggere “Einstein e io”, di Gabriella Greyson, fisica e scrittrice per Salani, su consiglio di una cara amica, anche lei fisica. La storia del primo amore di due geni, Einstein e Mileva, raccontata dalla voce della giovane ragazza, prima donna a studiare al Politecnico di Zurigo, colei che è diventata moglie e madre, per poi separarsi da Albert dopo vent’anni di relazione amorosa. Il racconto è in parte immaginato perché, a parte le numerose lettere tra i due giovani studenti e poi scienziati, la storia di Mileva si è persa all’ombra del marito e del genio, dopo il loro divorzio. Eppure è una storia che restituisce pari dignità alla mente di questa donna, primo amore di Albert ma non ultimo per lui, mentre lui per lei rimane primo e ultimo. L’autrice riesce a bilanciare la storia d’amore con quella della fisica che ha portato Einstein alla teoria della relatività ristretta e poi generale. Il racconto è però tutto al femminile e mette in luce quella zona oscura nella quale hanno lottato e continuano a lottare tante donne di scienza: Marie Curie, pre esempio, la grande scienziata osteggiata per la sua relazione amorosa da vedova con il fisico Paul Langevein; oppure Rosalind Franklin che fotografò il DNA ma alla quale non venne riconosciuto il Nobel per la scoperta, assegnato solo ai suoi colleghi uomini Watson e Crick. La storia della Fisica è il contesto nel quale l’amore è protagonista, l’amore travolgente tra due menti geniali, con le sfaccettature fanciullesche che si trovano nelle lettere di Einstein a Mileva, quelle del periodo all’apice del rapporto, dalle parole che ricordano alcune lettere di un altro genio innamorato come Mozart: “Streghetta adorata… Piccola fuggiasca… Monella di strada… (…) Mia dolce piccolina, (…) non riesco davvero a credere che rimarremo separati tutto questo tempo: solo ora mi rendo conto di essere pazzamente innamorato di te!” Eppure l’amore non regge di fronte all’impossibilità per la Mileva donna di continuare a essere scienziata, perché, una volta divenuta madre, si trova obbligata a dedicare tutta se stessa alla famiglia. E quello che mi ha intristito del libro è che, nonostante la possibilità di rivalsa che l’autrice concede a Mileva, almeno nella fantasia del romanzo, ancora oggi non è scontato per le donne poter essere scienziate a trecentosessanta gradi, senza arrampicarsi sugli specchi per non rinunciare all’amore e alla maternità.

La coppia Einstein Mileva starebbe bene nell’ultimo libro di Gabriele Romagnoli, “Senza fine. Le meraviglie dell’ultimo amore”, edito da Feltrinelli. Sarebbe un esempio da aggiungere alle varie storie d’amore che l’autore descrive e classifica in categorie dell’animo. Leggendolo l’avevo reso un’utile guida nella quale ritrovare alcune parti di me e dei miei amori. Romagnoli scrive dell’ultimo amore e ci arriva come fa sempre, raccontando le storie delle persone che incontra. Anche in lui percepisco una coerenza di intenti, riconosco la sua voce che avevo scoperto dalle “Navi in bottiglia” molti anni fa. Quel libro è uno scrigno di racconti minuscoli, perfetti e completi, ognuno una vita, una nave, una persona, descritta nell’essenza e riprodotta con la precisione e l’accuratezza della mano di chi costruisce un veliero dentro un contenitore in vetro dal collo stretto e lungo. In mezzo ai due volumi, tante storie sono passate attraverso la sua penna, tanta vita. E con una certa aspettativa mi ero immersa nella lettura del libro che credevo non avrei potuto finire. Era quello che il titolo mi prometteva. In effetti, a mio avviso, la promessa implicita è mantenuta: lo chiudi e vorresti ricominciare, perché, come scrive l’autore: “non è finita finché si ricomincia”. Parla di amore, di storie d’amore, con esempi e controesempi per arrivare a una tesi, l’unica possibile, quella per cui l’ultimo amore è quello che coincide con l’accettazione, prima di tutto di se stessi e dei propri limiti. E non ci si può accettare se non ci si conosce, non ci si può conoscere senza sbagliare mira, anche più di una volta, mancando il bersaglio e attraversando la propria sofferenza e quella altrui. Non ci si può accettare senza riconoscere nel profondo che l’amore è la fine dell’attesa: forse quella che siano gli altri a cambiare e non invece noi? Come sempre Romagnoli scrive di storie umane, le contrae nei particolari essenziali e le unisce in un destino, a volte è un viaggio, altre volte una ricerca di senso nella leggerezza, questa volta è la ricerca di sé in amore. E il suo punto di vista è come spesso originale: smettiamola con l’idea che sia il primo amore a non essere mai dimenticato. Concentriamoci invece sull’ultimo, quello eterno, quello in cui essere noi stessi e anche l’altro da noi e non poter scindere le due cose. Avevo paura di leggerlo, iniziando i primi paragrafi. Cosa mi avrebbe rivelato, come uno specchio, della mia ricerca in amore? Conserverò un dettaglio, quello che ha a che fare con la luce, con l’illuminazione. Ci vuole coraggio ad aprire le porte delle nostre stanze oscure, il buio ci acceca, ci fa sentire impauriti, sconfitti, afflitti, vinti. Ma solo così, abituando lo sguardo al buio e provando a illuminarlo con l’aiuto del cuore più che della mente, saremo capaci di accettarci davvero e camminare verso la luce.
Eppure, una volta arrivata all’ultima frase, l’ultima parola mi ha lasciato comunque all’ombra del dubbio di dove fosse il mio cuore tra primo e ultimo. Come se esistesse un solo primo amore e poi un secondo, un terzo, un quarto, fino all’ultimo… Non ero sicura di ritrovarmi in questa idea lineare e cronologica della vita e dell’amore. Ci ho messo del tempo a capire perché. Mi sono interrogata sui miei amori, sul primo, su quelli successivi, sulle volte che ho creduto fosse amore e invece no… eppure mentre ci credevo forse lo era… Ho provato a chiedermi: “Sarà quello che sto vivendo l’ultimo amore? Quello che vale la pena di continuare a costruire per tutta la vita se necessario, nonostante tutto? Come posso saperlo? Cosa me lo dimostra davvero? Il fatto che sia un amore che ha condotto al matrimonio e che il matrimonio duri da quasi vent’anni e che i suoi frutti sono due figli in piena adolescenza e come tali in piena ricerca di identità, con l’effetto naturale di sconquassare qualsiasi certezza abbiano attorno, specialmente quelle della coppia dei propri genitori?” Ho una tendenza naturale a mettere in crisi le mie poche certezze, anche quelle più consolidate. Una certezza non la considero tale solo perché ha resistito alla prova del tempo. Deve esserci qualcosa di più, una dimostrazione, la possibilità di controesempi da falsificare, o di esperimenti ripetuti per raggiungere lo stesso risultato. Ma la vita non è così. E dimostrare che l’amore che si vive è davvero l’ultimo, crederci fino in fondo non penso sia possibile. Così mi sono detta che non esiste un primo e un ultimo amore ma che ogni amore è primo e ultimo, come per ogni amore c’è un primo bacio e un ultimo, quello di poco fa, quello di adesso… È stato così che il mio cuore ha potuto ridersela: primo, secondo, terzo, ultimo, l’importante è solo amare. Essere ricambiati è magico, uno di quei miracoli possibili dai quali nasce nuova vita, ma se anche l’amore è unico e unilaterale, come per Cyrano e il suo pennacchio, è il sentimento in sé che è già tutto. Provarlo, verso l’altro da noi, farci travolgere eppure rimanere liberi, rimanere noi, capaci di sentire chi siamo veramente in quell’emozione, di vederci e riconoscerci nell’altro, questo basta a rendere ogni amore primo e ultimo: il tutto e il niente delle parole di Montale: “Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto”.

Quello che è importante, oltre queste riflessioni che sono forse solo la cornice più che la sostanza dell’amore, è che ognuno sia capace e sia messo in grado di conservare, non invadere o non lasciar invadere, quella ‘no man’s land’ che Nina Berberova descrive con femminile sapienza ne “Il Giunco Mormorante” (Adelphi). E che ritrovo citata nel bellissimo romanzo di George Simenon “Tre camere a Manhattan”.
La Berberova scrive:
“Fin dai primi anni della mia giovinezza pensavo che ognuno di noi ha la propria no man’s land, in cui è totale padrone di se stesso. C’è una vita a tutti visibile, e ce n’è un’altra che appartiene solo a noi, di cui nessuno sa nulla.
(…) In questa no man’s land, dove l’uomo vive nella libertà e nel mistero, possono accadere strane cose, si possono incontrare altri esseri simili, si può leggere e capire un libro con particolare intensità, o ascoltare musica in modo anch’esso inconsueto, oppure nel silenzio e nella solitudine può nascere il pensiero che in seguito ti cambierà la vita, che porterà alla rovina o alla salvezza. Forse in questa no man’s land gli uomini piangono, o bevono, o ricordano cose che nessuno conosce, o osservano i propri piedi scalzi, o provano una nuova scriminatura sulla testa calva, oppure sfogliano una rivista illustrata con immagini di belle donne seminude e muscolosi lottatori – non lo so, e non lo voglio sapere. (…) Ma non bisogna credere che quest’altra vita, questa no man’s land, sia la festa e tutto il resto i giorni feriali. Non per questa via passa la distinzione: solo per quella del mistero assoluto e della libertà assoluta”.
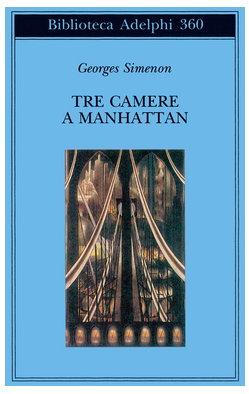
Invece Simenon descrive un incontro di due anime e l’inizio di un amore in un modo leggero come una piuma e così universalmente vero (per la mia esperienza almeno): “Lui la guardò. Era ancora senza trucco, senza nessun segno di civetteria, indifferente a quella vestaglia da uomo che la infagottata tutta, a quelle pantofole che doveva riacchiappare continuamente con la punta del piede. E fu proprio lì su quel pianerottolo, davanti a quelle porte anonime, in quella specie di no man’s land, che si diedero il bacio della giornata, forse il loro primo bacio d’amore; e, consapevoli entrambi delle tante cose che esso doveva racchiudere, lo fecero durare a lungo, dolcemente, teneramente, come se non dovesse finire mai, e ci volle lo sbattere di una porta per separare le loro labbra.
Allora lei disse semplicemente:
“Va’”
E lui scese, con la sensazione di essere un altro uomo”.

Quel bacio sul pianerottolo per me c’è stato. Proprio così, in una Manhattan che iniziavo a conoscere e che avevo esplorato da tre abitazioni diverse in più o meno tre mesi, ognuna una prospettiva sulla città e su me stessa. L’ultima, quella dove viveva la persona incontrata per caso a una fermata di autobus, quell’angelo fiammingo, come lo definivo allora, che avevo baciato per la prima volta in una casa non mia, dopo una serata a camminare in lungo e in largo prima a Sud e poi a Nord, di ritorno da un ‘date’ condito del migliore sushi che avessi mai assaggiato. Scrivevo dell’inizio di questo mio amore, a distanza di svariati anni:
My Fall (November 1998)
Foglie cadute e dipinte su una tela sono l’immagine che dopo vent’anni ritrovo memoria di un tempo che non ritornerà ma è insito nelle mie cellule: quel pomeriggio in cui passeggiavo in un parco in compagnia di un amore appena nato. Ero allora giovane, ancora priva di minuti, giorni, anni, accumulati nelle rughe della pelle. Guardavo il ragazzo che camminava davanti a me con gli occhi limpidi e resi ciechi dall’infatuazione. Mi sembrava un ‘Angelo Fiammingo’, dai capelli lunghi raccolti in una coda o sciolti sulla schiena, colore di un’Irlanda che intuivo dai libri ma dove non ero mai stata. La immaginavo come un quadro dai toni verdi dei prati e gialli oro antico, arancione dei capelli dei suoi abitanti. Il nuovo amore mi teneva per mano e mi accompagnava a conoscere i sentieri di un parco che per lui era casa, i campi dove si era nascosto da bambino, aveva giocato o lottato, il laghetto dove ogni albero era un amico da salutare e il salice era un fratello, le panchine dove si era seduto stanco, stonato, triste, allegro, solo o in compagnia, a leggere, riposare, baciare ragazze, contemplare la sua vita e quella di chi gli capitava a tiro, sui sentieri da Est a Ovest e da Nord a Sud, collegamenti e ramificazioni, pensati per non perdersi nel polmone verde di una città chiamata Grande Mela e costruita come una scacchiera. Nel blu del cielo spicca il giallo delle foglie cadute e salvate dal mio desiderio di conservare quella ‘Fall’, mettendole a seccare in un vocabolario pesante che allora mi serviva a studiare una lingua che volevo diventasse la mia, volevo masticarne le parole perché mi aiutassero a esprimere nuove zone del mio essere. Il volume era antico, pesante, adatto a cercare in ogni parola le sfumature, sottili come le pagine di carta fine, tra le quali mettevo fogli di giornale a custodire foglie raccolte. Volevo fermare il tempo di quella caduta nell’amore. E lo rivedo quel giorno andato, lo rivivo in un quadro che composi e che ha dentro tutto il mio sentimento di allora, difficile da ritrovare in me oggi, eppure non scomparso per sempre, custodito invece in una zona della memoria e in un’immagine di leggerezza, di volo, di tuffo e di desiderio esaudito, quello di amare ed essere ricambiata, senza riserve o condizioni, con l’accettazione che proviamo osservando la natura e le sue stagioni, la nebbia d’autunno, le foglie pronte a cadere, quelle già stese al suolo, tappeto che diventerà terra dove appoggeremo i nostri passi, della quale siamo fatti e alla quale torneremo un giorno.
