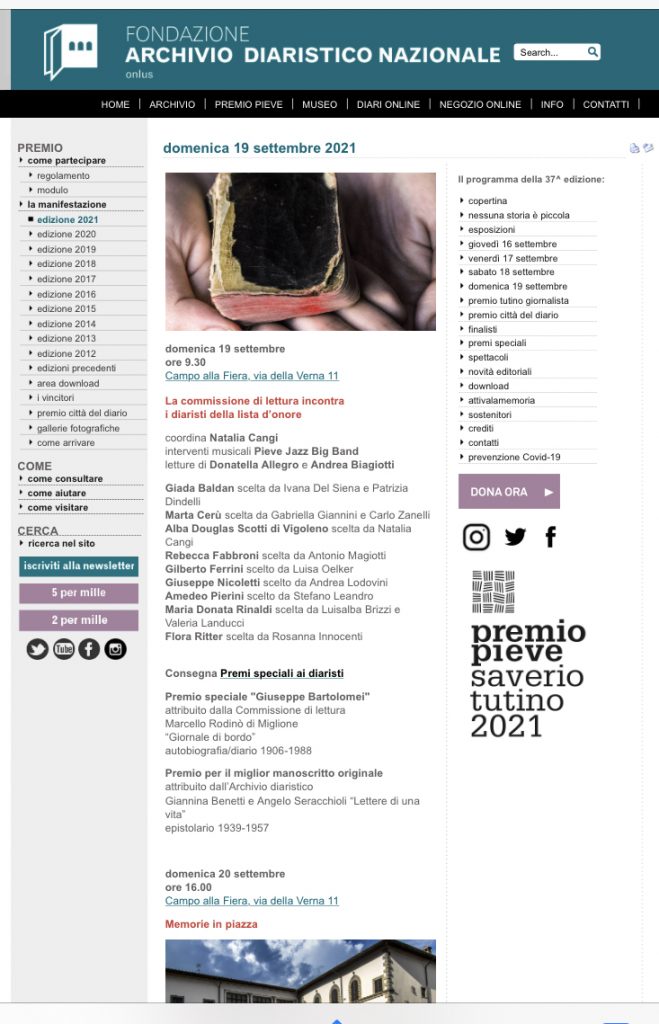Eco
Qualche settimana fa ho avuto la notizia di essere stata inserita nella lista d’onore del Premio Pieve, alla sua trentasettesima edizione. Non sono tra i finalisti di questo anno 2021, ma il mio scritto epistolare, l’insieme delle mail che mandavo da New York negli anni tra il 2001 e il 2005, alla famiglia allargata di amici e parenti, è stato apprezzato come diario degno di una menzione. Ne sono onorata e parteciperò alla mattinata del 19 Settembre, intitolata “Leggere e scrivere i diari”, un appuntamento pubblico, tra quelli nell’ambito del Premio, riservato al racconto delle storie che compongono la rosa degli autori scelti dalla Commissione di lettura per la Lista d’onore. L’incontro sarà accompagnato da letture tratte dai diari e da sottolineature musicali. La direttrice della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Natalia Cangi, mi ha comunicato la notizia dicendo che il mio scritto “ha molto colpito i lettori della commissione di lettura del Premio Pieve Saverio Tutino perché ricostruisce molto bene un periodo della sua vita, che sembra essere caratterizzato da una voglia continua di interrogarsi sulla realtà costruita, di non accontentarsi dello status quo, di cercare sempre il concretizzarsi di un sogno di vita più giusto, più sereno, più a misura umana. Un racconto dotate di coerenza che abbiamo molto apprezzato”.

Rileggendo le mie lettere, trovo una me curiosa, stupita delle piccole cose riguardanti quel mio nido a Manhattan, che si popolava dei miei due figli. Mi fa tenerezza quella voce, che raccontava intimamente cose di sé e delle relazioni costruite in una lingua non madre, con la quale riconoscere la stessa me in quella me diversa perché raccontata con parole nuove. Non che le lettere abbiano una valenza riguardo alla scrittura, sono un po’ cronache, un po’ riflessioni intime, un po’ un tentativo di mantenere legami con le persone che avrei forse frequentato se fossi rimasta in Italia allora. Ma raccoglierle e inviarle mi ha consentito di incorniciare una parte importante della mia vita, come un quadro appeso a un chiodo, lo guardo e oggi riprendo il filo di quella vita, rispondendo a questa domanda, che negli anni mi sono sentita porre di continuo….
Ti sei trasferita in Umbria da Manhattan? Non ti manca? Mi chiedono.
E io che penso? Penso che mi mancano gli alberi, non so cos’altro mi manchi di quella vita ormai lontana nel tempo, di quella città verticale, che ho amato in tutte le sue parti, dalle viscere della metropolitana alle cime dei grattacieli. Mi mancano gli alberi. Gli alberi di Central Park. Central Park tra la Novantasettesima e la Centesima strada, la zona ovest di un rettangolo verde, sul quale si affacciava il nostro condominio. Il nostro condominio aveva un nome, 372 CPW, la sigla del palazzo in cui vivevo con Breon. Breon del quale mi ero innamorata, che aveva una storia per ogni albero del parco, come il salice sulla riva del laghetto. Il laghetto nel parco, dove una volta era caduto un ragazzino. Un ragazzino salvato da Breon, eroe solitario prestato a una catena umana, dalla riva al bordo del ghiaccio, ultimo anello nel punto in cui il malcapitato annaspava. Annaspava ma era stato ripescato da un ragazzo biondo, capelli lunghi da angelo fiammingo, era corso a casa, a cambiarsi e riscaldarsi, senza che nessuno lo ringraziasse, il salvato ignaro di chi fosse il salvatore. Il salvatore lo conoscevano gli alberi. Gli alberi come il salice piangente, dal tronco largo quanto l’abbraccio di quattro persone, quello che Breon salutava ogni volta che passeggiava attorno al laghetto. Il laghetto era l’oasi di uccelli migratori, specchio per loro e per un salice i cui rami in inverno, tendevano spogli al ghiaccio. Il ghiaccio non mi manca ma il salice sì, la sua ombra gentile sotto cui sedermi, in quell’angolo appartato di parco, da sola o in compagnia di Breon. Da sola o in compagnia del piccolo Simon e della minuscola Lucia. Simon e la minuscola Lucia parlavano una lingua strana, mi mancano gli echi delle prime parole di quei due bambinetti, le loro fattezze talmente irlandesi che io non sembravo nemmeno la mamma. La mamma che si mescolava alle tate di altri bambini, le cui madri erano occupate dal lavoro. Il lavoro mi mancava allora, come oggi mi manca quella visuale da tata. Una tata italiana a zonzo nel parco, piccola, capelli corti scuri e occhi marroni, a passeggio tra gli alberi con due bimbi chiarissimi, dai capelli biondissimi e gli occhi azzurrissimi.
Ti sei trasferita in Umbria da Manhattan? Non ti manca? Mi chiedono.
E io che penso? Penso che mi manca la me stessa di allora, trattenuta in me a fatica, solo una eco di quello spirito di avventura, di quelle relazioni, di quell’entusiasmo, di quello sguardo su un mondo nuovo che avevo voluto raggiungere a ogni costo, del quale mi sentivo parte, con l’orgoglio degli occhi che si specchiavano nelle persone che incontravo, anche loro in cerca. In cerca di cosa? Mi chiedo, gli echi di quella vita persi tra gli alberi di un bosco molto più antico, dove passeggio senza incontrare anima viva, dove ragazzi camminano, i bambini di allora. Allora nel parco le tate chiacchieravano, lasciando i bambini giocare, le bici sfrecciare, i maratoneti correre o arrancare, i taxi gialli arrotare l’asfalto, i turisti ciondolare, e i pendolari attraversare da un lato all’altro la scacchiera, in lungo e in largo, da casa al lavoro e dal lavoro a casa. Dal lavoro a casa, da casa al lavoro, mi manca quel flusso di energia umana, quegli alberi fermi ma non immobili, quei testimoni di voci e di vite, come la mia, libera e pioniera, un seme trasportato dal vento, che prova a mettere radici in una terra più fertile di quella da cui proviene.
Ti sei trasferita in Umbria da Manhattan? Non ti manca? Mi chiedono.
E io che penso? Penso che mi mancano le persone della piccola grande comunità nel palazzo dove abitavamo. Dove abitava Bella, insegnante di letteratura in pensione, Bella e le sue poesie, o quelle dei suoi studenti, in fondo era uguale. Era uguale a me Bella, così profondamente diversa, la incontravo all’ingresso del palazzo, le sue fotocopie in mano, un saluto e una poesia, accompagnata da un fiume di parole. Parole importanti da scambiare, specialmente quando si è soli e gli anni avanzano, i figli e i nipoti chissà dove. Gli amici in quel posto dal quale non arrivano echi. Echi degli anni di Bella, quanti ne aveva? Aveva l’età del salice forse? Forse. Non lo sapevo allora né tantomeno oggi, eppure la vedo, capelli bianchi arruffati, pantaloni larghi, maglione un po’ sghimbescio, borsa di stoffa piena di fogli, di fotocopie, di parole, di storie: storie sempre le stesse, ogni volta un po’ diverse. Diverse come lo era da lei suo marito, amorevole ma silenzioso. Silenzioso e schivo, anche lui un insegnante, in pensione in un appartamento dove una volta ero stata invitata. Invitata a entrare dove non c’era spazio per muoversi, libri e fogli ovunque, poesie e parole. Parole e poesie di Bella, volate via come foglie.
Ti sei trasferita in Umbria da Manhattan? Non ti manca? Mi chiedono.
E io che penso? Penso che manca la piccola grande comunità nel palazzo dove abitavamo. Dove abitava Cigal con il suo sogno di un Kibbutz a Manhattan. Manhattan aveva accolto anche lei, architetto, votata a fare la mamma a ogni costo, come quello di restare nove mesi in un letto. Un letto che non è un problema, se hai la certezza di nutrire un sogno, di volerlo così tanto che sacrificheresti qualunque cosa, anche il tuo corpo se necessario. Era necessario a Cigal, ne parlavamo a fine pomeriggio, lei sdraiata in quel letto, io di ritorno dal parco, quando proprio non sapevamo come far passare le ultime ore prima del sonno dei giusti, dei bambini a due anni, quell’età che rincorrevo sperando di superarla presto, e che oggi vorrei non aver lasciato indietro tra gli alberi. Gli alberi che Cigal aveva amato in Israele, una terra alla quale non sapeva rinunciare, come alla sua comunità nomade. Da nomade creava legami tra le donne del condominio, inventava scuse per vedersi, per offrire il suo tè dalle sfumature verdi alla menta, avvicinava nella sala giochi le possibili adepte del suo kibbutz virtuale, mamme con i bambini, desiderose di scambi tra lingue diverse: una giapponese, una coreana, una tedesca, un’israeliana, un’italiana, un’egiziana, e a volte anche un’americana. Americane volevamo esserlo un po’ tutte, ognuna con il suo fardello, che Cigal alleggeriva regalando condivisione senza riserve: amicizie, famiglia, casa, soprattutto cibo. Il cibo di Cigal mi manca: le sue zuppe di verdure a pezzi grandi, immerse nel brodo denso e caldo, in cui galleggiavano minuscoli crostini secchi. Secchi come Israele, dove si mangiano le insalate divertenti, che chiamarle insalate fa ridere, così piene di tutto quello che c’è nel frigo, dello yogurt, della frutta, dei cereali croccanti e del miele, miele che addolcisce la vita.
Ti sei trasferita in Umbria da Manhattan? Non ti manca? Mi chiedono.
E io che penso? Penso che mi mancano le ombre che vedevo dalla mia finestra. La mia finestra, una tra la moltitudine di affacci sulla stessa strada, le cui luci rimanevano accese anche di notte, nella città che non dorme mai. Non dormiva mentre io mi addormentavo davanti a uno spicchio di mondo, il buio interrotto dalle luci di altre finestre, scorci di altre vite come la mia, in transito. Del transito restano gli echi tra gli alberi nel parco, fruscii di foglie cadenti, voci di bambini ormai cresciuti, parole scappate a Bella che regala foglie di poesia: “Te ne regalo una, prendila. La poesia cura. La poesia nutre gli animi. La poesia ferma il tempo, non tramonta, rimane viva. La poesia ci ricorda chi siamo, un soffio e via, un momento abbracciamo un albero, subito dopo siamo un’eco lontana, tramandata dai rami di un salice”.
Ti sei trasferita in Umbria da Manhattan? Non ti manca? Mi chiedono.
E io che penso? Penso che mi mancano le biblioteche cittadine, dove andare a studiare, o le librerie. Le librerie come le piccole case dei libri, oppure i grandi magazzini tipo Barnes and Nobles, dove puoi sederti nel caffè, a scrivere e leggere e pensare, anche per ore. Ore come quelle scandite dall’orologio nella vecchia New York Public Library, la biblioteca storica newyorkese, con le sculture dei due leoni ad accoglierti in cima alla scalinata maestosa. Maestosa era la biblioteca all’interno, odore di legno e di libri, lampade dalla luce calda a illuminare i pensieri assorti e silenziosi, di un silenzio interrotto solo dal fruscio della carta. La carta stampata, mi manca la carta dei libri vecchi, usati, a migliaia, ordinati siglati e riposti nelle altissime scaffalature della mia libreria preferita, dal nome che significa filo, il filo dell’inchiostro che si srotola per formare parole. Parole vecchie e parole nuove, come Strand che vuol dire filo, filamento, e che è il nome della più grande libreria dell’usato newyorkese, contenitore di così tanti libri che se li metti in fila arrivi da qui a 18 miglia. Tante miglia non le riuscivo a immaginare, se non in chilometri, una fila di libri che ricopre circa trenta chilometri? I chilometri sono uno strano modo di misurare la quantità di libri in una libreria che aveva aperto i battenti a un angolo di Union Square ma che io avevo conosciuto nella sede molto più gigantesca che si trovava su Fullton Street a due passi dalle due torri. Le due torri la sovrastavano in altezza quell’immensa libreria ma lei rispondeva in larghezza perché varcare la soglia era lo stesso che perdersi. Perdersi a cercare il libro che non trovi, perdersi a immaginare di essere sbalzati nel racconto di Borges, di infilarsi in uno dei corridoi e trovare chi scrive edizioni su edizioni dello stesso libro, perché devono esserci tutte, usate, riciclate, a metà prezzo ma come nuove. Nuove come la Nuova York, isola tra due fiumi e un oceano, simbolo di nuova vita per chi arriva dal vecchio continente e scorge da una nave la statua con la torcia in mano dal colore verde. Un verde diverso da quello dell’acqua riflessa nel cielo. Cielo che a Manhattan è più basso che altrove, i palazzi lo inseguono per toccarlo e grattarlo e tu che arrivi in cima guardi quel cielo e pensi: e oltre? Oltre c’è quello che vuoi immaginare, il futuro che hai deciso di costruire in questa terra nuova, niente di più e niente di meno di quel sogno. Un sogno lo avevo ed era di scrivere uno di quei libri in inglese. L’inglese che masticavo male ma che mi permetteva di scrivere senza inibizioni e senza condizioni. In inglese una fisica poteva essere anche scrittrice nella mia testa divisa. Divisa a inseguire le voci degli altri, dimenticando la mia, come nella sala degli specchi dove ogni specchio cattura un po’ di te e non sai più chi sei alla fine, dove sei, dove cercarti. Dove mi cercavo in quelle prime settimane di vita in un appartamento a Fullton Street? In strada no, era troppo dispersivo, avrei potuto volatilizzarmi assieme al vapore che usciva dai tombini in certe ore alla mattina presto o alla sera. Alla sera o alla mattina, mi cercavo per ore da Strand, inseguendo il filo dei libri, prima di avventurarmi tra le persone e la nuova lingua, prima di rincasare e ritrovarmi sola in una città immensa, sola e piccolissima come una formica in mezzo a tante formiche.
Ti sei trasferita in Umbria da Manhattan? Non ti manca? Mi chiedono.
E io che penso? Penso che mi manca il Museo Americano di Storia Naturale, dove ho conosciuto Niles Eldresge, Stephen J. Gould, Brian Green e molti altri grandi divulgatori, tra i quali il mio preferito, Edward Olson Wilson, il migliore amico delle formiche. Una formica me l’aveva disegnata dedicandomi il suo libro sulla vita, perché lui la vita sulla terra la studiava fin da bambino e la studiava proprio a partire dagli insetti, dalle colonie. Colonie animali, dalle quali ispirarsi per la nostra colonia di esseri umani, che ci siamo accasati su un pianeta di tutti senza preoccuparsi di chi ci aveva preceduto e continua a coabitare con noi. Noi che siamo artefici ignari di una estinzione di massa, la sesta, quella che riduce ogni giorno, ogni ora, ogni minuto la varietà delle specie viventi sul pianeta, la biodiversità. La biodiversità è rappresentata in quel museo che ho amato come un’estensione della mia casa, su una gigantesca parete, piena di ramificazioni, riguardanti Domini, Regni, Phylum, Classi, Ordini, Famiglie, Generi e Specie, nomi per inquadrare la vita, dal primo organismo vivente fino a quella me piccola piccola, in quella città enorme, mai uguale a se stessa, in perenne cambiamento, densa di vita e di morte, di chiari e scuri, di eccessi e mancanze, di vuoti dell’anima, da riempire in gruppi di aiuto… gruppi di aiuto anonimi, dove perdere il proprio anonimato e riconoscersi nelle sofferenze degli altri, mai uguali alle nostre, eppure così comuni all’essere umani.
Ti sei trasferita in Umbria da Manhattan? Non ti manca? Mi chiedono.
E io che penso? Penso che mi mancano le due torri. Di torri da dove vivo ora ne vedo tre, quella civica, quella circolare e quella del campanile, ma non sono di vetro, non riflettono e bucano il cielo. Il cielo attraverso il quale un funambolo stese un filo. Un filo d’acciaio, da una torre all’altra, per compiere l’impresa di una vita. Una vita dedicata all’arte del funambolismo, quella di Philippe Petit. Philippe ‘Petit’ lo era forse, di statura, ma su quel filo, con il suo bilanciere, sospeso tra le due torri, era minuscolo e grandissimo a un tempo. Tempo trapassato remoto, ora che neanche le torri sono lì a ricordare. Ricordare potrebbe chi l’ha visto quel piccolo uomo, ma la memoria è stata bucata da due aeroplani. Due aeroplani lanciati contro due torri in quella mattina di Settembre. Settembre, il mese della Fall, della caduta. Caduta delle foglie, di vite ignare e di due torri…
(…)