
Sospensione

Si dice che un buon racconto debba ascendere e discendere la curva di una parabola: una situazione iniziale evolve verso una forma di conflitto che genera una trasformazione e una risoluzione. Eppure qualche tempo fa ho letto i racconti della raccolta “Equilibri sospesi” (Progetto Cultura) di Marilena Votta e mi sono trovata, come prometteva il titolo, acchiappata dalla parola sospensione. Lo stile dell’autrice è particolare, ai confini con un testo poetico. Le frasi sono brevi e le parole tra l’onomatopeico e il sensoriale. La sua scrittura si vede e si tocca e in una delle nostra conversazioni mi ha raccontato che per ogni storia parte da un’immagine, un fotogramma che le appare e dal quale dipana la sua scrittura. I racconti di questa raccolta hanno un elemento in comune: riguardano personaggi nel momento del cambiamento. Ci sono le premesse, ci si addentra nelle emozioni di chi sta affrontando un momento sulla soglia del cambiamento. si percepisce la tensione del salto imminente ma ci si ritrova sospesi, pur arrivando da qualche parte. Molte delle storie potrebbero avere un esito tragico, violento, negativo, ma il beneficio della sospensione è poter immaginare che no, che la situazione si risolva bene, che il personaggio possa compiere la sua rivoluzione e trasformarsi con noi che leggiamo e che immaginiamo lo scenario più felice.
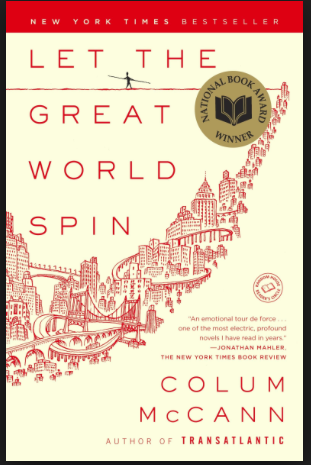
Ho trovato questa modalità di raccontare molto attraente. E la sensazione di sospensione mi ha riportato a un magnifico romanzo che ho letto qualche anno fa, “Let the great world spin” (penguin Random House), tradotto in Italiano come “Questo bacio vada al mondo intero” (Bur Rizzoli) di Colum MacCann, del quale amo l’incipit, oltre all’intreccio delle storie dei personaggi (lo riporto in Inglese perché così l’ho letto): “Those who saw him hushed. On Church Street. Liberty. Cortlandt. West Street. Fulton. Vesey. It was a silence that heard itself, awful and beautiful. Some thought at first that it must have been a trick of the light, something to do with the weather, an accident of shadowfall. Others figured it might be the perfect city joke—stand around and point upward, until people gathered, tilted their heads, nodded, affirmed, until all were staring upward at nothing at all, like waiting for the end of a Lenny Bruce gag. But the longer they watched, the surer they were. He stood at the very edge of the building, shaped dark against the gray of the morning. A window washer maybe. Or a construction worker. Or a jumper. Up there, at the height of a hundred and ten stories, utterly still, a dark toy against the cloudy sky. He could only be seen at certain angles so that the watchers had to pause at street corners, find a gap between buildings, or meander from the shadows to get a view unobstructed by cornicework, gargoyles, balustrades, roof edges. None of them had yet made sense of the line strung at his feet from one tower to the other. Rather, it was the manshape that held them there, their necks craned, torn between the promise of doom and the disappointment of the ordinary. It was the dilemma of the watchers: they didn’t want to wait around for nothing at all, some idiot standing on the precipice of the towers, but they didn’t want to miss the moment either, if he slipped, or got arrested, or dove, arms stretched. Around the watchers, the city still made its everyday noises”.

In apertura, Philippe Petit si prepara per camminare sul cavo d’acciaio tirato tra le due torri gemelle di Manhattan. Era l’8 Agosto del 1974 e il ragazzo sul filo aveva 24 anni, l’età perfetta per compiere il più sbalorditivo “crimine artistico” di tutti i tempi. A più di quattrocento metri di altezza dal suolo, una figura piccolissima, vestito di una tuta nera attillata, ha camminato per quasi un’ora avanti e indietro otto volte su un cavo di acciaio. Il romanzo inizia con lo sbandamento di chi assiste a una scena che ha dell’incredibile eppure accade: un funambolo ha deciso di attraversare l’ignoto spazio di cielo tra due grattacieli, che lui vede come due torri, camminando su un filo, senza sicurezza, senza rete… È sospeso come un uccello e la sua camminata è una danza tra i grattacieli che in breve diventeranno il World Trade Center, all’altezza di quello che sarà il famoso ristorante Windows of the World, allora ancora un cantiere. Aiutato dai suoi amici e compagni di crimine, Philippe seppe eludere qualsiasi sistema di sorveglianza, portò il cavo in cima alla torre Sud, lo tese tra i due grattacieli, si mise la sua tuta nera da funambolo, imbracciò il bilanciere e mosse il primo passo e i successivi, realizzando la missione degna di tutta la sua vita.
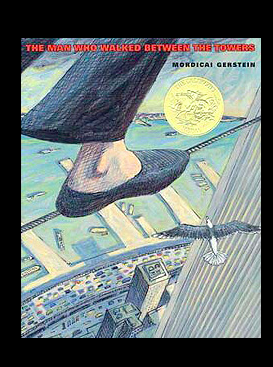
Ho incontrato per la prima volta quest’uomo leggendario in un libro per bambini, “The man who walked between the towers” di Mordicai Gerstein. Me lo avevano regalato a New York e lo leggevo tra le tante storie della buonanotte ai miei figli ancora piccoli. Era una di quelle favole vere, magnifiche, di quelle storie che a leggerle sembrano solo frutto della fantasia. E invece Philippe era vero, un essere umano in carne e ossa che aveva realizzato uno dei suoi sogni a Manhattan e ci aveva vissuto per diversi anni. Mia cognata Deirdra, che oggi vive in Nebraska e che non vedo mai, era una ragazza in quegli anni e di Philippe era amica, lo incontrava ogni tanto, artista di strada e funambolo tra i grattacieli. Fu lei a mandarci un film che racconta la vita dell’artista del filo e l’impresa soprannominata “The Walk”.

Prima di arrivarci Philippe si è allenato per anni e ha camminato tra le guglie di Notre Dame e tra altre torri nella sua Francia d’origine, si è allenato per un anno intero programmando l’obiettivo di una vita.

Il romanzo di Colum McCann inizia con i nasi in aria dei passanti, fermi, folla in transito, osservano increduli la piccola figura nera che comincia i suoi passi sul cavo. Da quel momento le storie di vari personaggi si intrecciano nella New York di quel giorno, di quell’anno, fino alla fine del romanzo, quando il racconto della traversata ci travolge e si conclude. Le persone che abitano questa storia corale non si conoscono, ma in qualche modo si incontreranno anche se solo sfiorandosi, in quella giornata appesa a un cavo. Non sembrano avere elementi in comune, eppure ognuno di loro ha una storia sospesa, ognuno è alle prese con la sua camminata sulla sua corda tesa, e per ognuno di loro non è l’arrivo o l’epilogo che conta ma quella giornata di attraversamento, di transito.

Ho letto il libro qualche anno fa e mi ha riportata nella New York che conosco solo dai film e dai racconti di Breon, mio marito, che quegli anni settanta li ha vissuti, ragazzino di strada con le sue due sorelle, in una Upper West Side divisa tra le gang di quartiere che si contendevano centimetri di strade: portoricani, bianchi e neri, ai tre vertici di un triangolo dalle relazioni indeformabili. Breon è nato a New York e ha origini irlandesi, è immigrato di seconda generazione. I suoi amici sono di tutti i colori. E la sua infanzia la immagino un po’ come West Side Story. Quando l’ho incontrato in quelle strade che avevo imparato a conoscere, lo prendevo in giro chiamandolo il sindaco della Upper West Side, perché a ogni passo qualcuno lo salutava. Ma questa è un’altra storia.

Forse il mio amore per il romanzo di McCann è frutto di un amore a prescindere per New York e i suoi abitanti. Ma non è così. Si tratta di un capolavoro di letteratura. Lo attraversi e ti senti sulla corda leggendo, nella personale impresa di vivere e trovarti in transito, come i personaggi del romanzo. Non si riesce a non amarli questi esempi di umanità nei quali l’autore ci cala, le loro sofferenze, le loro storie di immigrazione, di sfide irrisolte, la loro diversa collocazione sociale, in mondi talmente separati che sembra impossibile si incontrino, eppure sono vicini e può succedere che si intreccino con la corda tesa da Philippe.
La magia di New York è proprio questa, la diversità umana e la sensazione che ogni impresa sia possibile, anche la più insensata, nel puro stile “Yes We Can”. Manhattan è ancora il simbolo di un’America che non è quella del fantoccio che ha soffocato il sogno cominciato nel 2008, ma sono convinta che risorgerà. Dobbiamo solo arrivare dall’altra parte riuscendo a mantenere l’equilibrio, nonostante.

Racconta Philippe in un video che, dopo l’impresa, quando era in manette e stava per essere condotto di fronte a un giudice, un giornalista lo ha avvicinato per chiedergli: “Perché lo hai fatto?” E lui risponde, con la voce e gli occhi di allora: “Ero scioccato dalla domanda, non ci avevo davvero mai pensato e la mia risposta è stata semplice: quando vedo un posto fantastico per stendere il mio cavo, non posso resistere”.

E continua: “È molto importante in qualsiasi arte, ma soprattutto nell’arte di vivere, mantenere la centralità dell’obiettivo, la concentrazione mirata a dare il meglio di noi, qualsiasi cosa ci troviamo a fare. La vita è meravigliosa e dobbiamo essere felici. Per me è stata una grande avventura. E non ero solo, ero circondato da amici e ancora oggi vedo quel momento come il migliore della mia vita”.

Philippe ha scritto un magnifico “Trattato di funambolismo” (Editore Ponte alle Grazie)in cui racconta l’arte come vita o la vita come arte, lasciando la sua eredità di pensiero che ognuno può sperimentare, qualunque sia la fune da attraversare: “Il funambolo non è una risposta al problema dell’equilibrio”, scrive nelle prime pagine, raccontando i primi esercizi da fafe sulla corda tesa. “Guardate risolutamente ciò che è teso davanti a voi. Ecco. Siete di fronte al cavo. Tutto è diverso ora che il filo è là. Puntate lo sguardo all’estremità, il traguardo, e tentate una traversata. Non cercate la corteccia dietro di voi, ma saltate al primo accenno di squilibrio. La traversata sarà una successione di equilibri: su un piede, poi sull’altro… Non dovete cadere. Quando sentite di essere instabili, resistete a lungo prima di girarvi verso terra, poi saltate. Non bisogna più sforzarsi di stare fermi, bisogna guadagnare terreno. Conquistare! Il filo trema. Si vorrebbe imporgli la calma con la forza, mentre invece bisogna spostarsi con dolcezza, senza disturbare il canto della corda.”
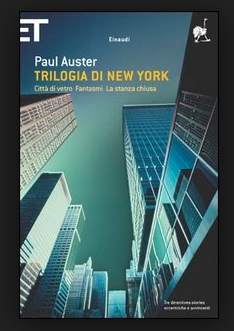
Il trattato ha una bellissima introduzione di Paul Auster, l’autore di “The New York Trilogy” (Penguin Book), un libro che ho scelto come insegnante di inglese nelle prime settimane di esplorazione in quella metropoli. Me lo portavo dietro ovunque e cercavo quasi ogni parola sul vocabolario, ritrovandola poi nel quotidiano in un modo o nell’altro: “Ho visto Philippe Petit per la prima volta nel 1971” scrive Auster introducendo il trattato di Petit. “Ero a Parigi e passeggiavo lungo il Boulevard Montparnasse, quando incrociai un capannello silenzioso di persone immobili sul marciapiede. (…) mi feci strada fra gli spettatori e, alzandomi sulla punta dei piedi, intravidi nel centro un uomo giovane e minuto. Era tutto vestito di nero: le scarpe, i pantaloni, la camicia, perfino il cilindro di seta pesta che aveva in testa. I capelli che uscivano dal cilindro erano di un biondo rossiccio chiaro, la faccia era così pallida e smunta che sul momento pensai che portasse una maschera bianca. Il giovanotto faceva giochi di prestigio, andava in monociclo e presentava trucchi di magia. Maneggiava palle di gomma, birilli di legno e torce infuocate (…) faceva tutto in silenzio. Sul marciapiede era tracciato un cerchio col gesso e lui, meticolosamente, teneva lontani gli spettatori da quello spazio, con gesti mimici persuasivi, proseguendo lo spettacolo con tale determinazione e intelligenza che era impossibile smettere di guardarlo. Al contrario di altri artisti di strada, non lavorava per la gente. Pareva piuttosto che invitasse il pubblico a condividere il lavorio dei suoi pensieri, lo rendesse consapevole di qualche ossessione indicibile e profonda che lo possedeva. Ma nei suoi gesti non c’era nulla di strettamente personale; tutto veniva svelato metaforicamente, a un secondo livello, attraverso il medium della rappresentazione. La sua destrezza era assoluta, autocoinvolgente, come un discorso fra sé e sé. Aveva elaborato combinazioni complesse, strutture matematiche intricate, arabeschi di assurda bellezza, ma quei gesti erano semplici. Così riusciva a emanare un fascino ipnotico”.

E ipnotica è anche la scrittura di Petit, ogni frase un pratico consiglio per l’aspirante funambolo, ma anche una metafora essenziale per vivere la realizzazione della propria missione: “La ricerca dell’immobilità è il mistero della danza sulla corda. La linfa. Poco importa il tempo necessario per raggiungerla. Dovrei dire per avvicinarla? Per avvicinarla il funambolo si fa alchimista. Rinnova il suo tentativo lungo tutto il filo senza mai inventare il Regno dell’Immobile dove le braccia sembrano pendere, inutili, lungo un corpo che pesa dieci volte il suo peso. Il sapore d’un secondo d’immobilità — se il filo ve lo concede — è una felicità intima”.
C’è un’idea della missione e della trasmissione di conoscenza che ribalta la prospettiva unilaterale del rapporto tra maestro e discepolo: “La gloria di soffrire mi è indifferente. D’altronde, non credo in niente. Non c’è che il superfluo che m’incanti. I limiti, le trappole, le impossibilità, vado loro incontro ogni giorno. Ritengo che la frusta sia necessaria, a condizione che a maneggiarla sia l’allievo, non il maestro”. E c’è la passione, il desiderio, l’importanza dei sogni e della speranza: “Uomo dell’aria, tu colora col sangue le ore sontuose del tuo passaggio fra noi. I limiti esistono soltanto nell’anima di chi è a corto di sogni. (…) L’errore è partire senza speranza. Lanciarsi senza fierezza nella figura che si è certi di mancare”. Il funambolo “vuole allineare alla verticale dei suoi pensieri i suoi dubbi e i suoi timori per issare fino a sé il coraggio che gli resta. (…) In quel momento è un pezzo della mia esistenza che regalo, o abbandono, dipende. Ricorderò soltanto l’entrata, la presa del bilanciere, la prima traversata, l’istante del dubbio e il saluto finale”.

Infine c’è la solitudine imprescindibile dell’essere umano, trasformata nella gioia a prescindere di colui che compie la propria rivoluzione: “Solo sul filo, si circonda di un’allegria aspra e selvaggia, compiendo traversate spensierate e prive di ordine nell’umidità della sera. Appende il bilanciere alla passerella prima di prender posto in cima al palo in seno a un frammento di spazio nero e ghiacciato, per accogliere senza angoscia la notte che viene.”

Secondo Paul Auster , che vide la camminata di Philippe tra le torri di Nôtre-Dame: “Diversamente dalle rappresentazioni delle altre arti, l’esperienza del cavo a grande altezza è diretta, semplice, immediata, non richiede la minima spiegazione. L’arte è la cosa stessa, una vita nella sua più nuda evidenza. Se c’è bellezza, è la bellezza che sentiamo in noi. (…) Meticoloso come un rapinatore che progetta un colpo, Philippe ha architettato il suo spettacolo in silenzio. Niente conferenze, niente pubblicità, nessun manifesto. La sua purezza era impressionante. In quale guadagno poteva sperare? Se il filo si fosse spezzato, se l’installazione fosse stata difettosa, sarebbe morto. D’altra parte, cosa gli avrebbe reso la riuscita?”

Quando ascolto musica dal vivo penso ai musicisti come funamboli, la loro corda il loro strumento, se non proprio la musica, le note stesse della partitura. Chi suona diventa una cosa sola con quella stessa corda descritta da Philippe Petit: “Volevate sentire l’asse del filo. Sta per diventare la vostra spina dorsale. Ogni secondo raspa come una pietra per affilare. Un dolore senza fine si impadronisce del vostro corpo, lo contrae muscolo dopo muscolo. Se si resiste al limite dell’insopportabile, il supplizio si estende alle ossa, che sembrano sul punto di spezzarsi lungo il filo. Sarete uno scheletro in equilibrio su una lama. Oltre questo limite milioni di incantesimi, non esenti da paura, vi attendono. Ancora oltre, una pazienza senza desiderio darà a ciascuno dei vostri pensieri una densità reale. Allora, siate pigri fino al delirio!”

Ero ad ascoltare il violoncellista Paolo Andriotti, che eseguiva le Suite di Bach dal tramonto all’alba nel Teatro di Villa Pamphilij, Lo guardavo stare sulle corde del suo strumento, diventarne parte e per un tempo che non saprei definire mi ci aveva portata, ero anche io a camminare sul filo, come credo si sia sentito chi ha visto Petit in una delle sue camminate danzanti. Chi raggiunge quello stato di unicità con la corda ha un impatto su chi lo osserva, chi lo ascolta, chi lo incontra. Tra musicisti credo sia normale sperimentare questa sensazione ma non scontato. Richiede concentrazione, dedizione disciplina. Quello che trovo magico è quando il loro stare sulla corda si unisce, per esempio in duo, in trio, in orchestra. Ancora di più, in questi casi, la musica diventa il tramite per accedere a quello stato magnifico anche per chi ascolta.

Mi è capitato ascoltando il duo “Labor Limae” (il nome che hanno scelto di darsi è in perfetta armonia con le indicazioni di Philippe Petit dell’allenamento del funambolo), i pianisti Andrea Feroci e Francesco Micozzi che suonavano a quattro mani l’adattamento al pianoforte della Prima Sinfonia di Mahler: quasi un’ora di musica ininterrotta, durata quell’attimo che bastava a contenere l’infinito.

E recentemente mi è successo ascoltando l’Orchestra di Santa Cecilia che eseguiva la Sesta Sinfonia di Mahler diretta da Daniele Gatti. Ero rapita dal suo essere una cosa sola con la musica e con i musicisti. Non aveva leggio, lui dirige a memoria, e forse proprio per questo il suo rapporto con le note e gli elementi dell’orchestra è ancora più diretto, diversi corpi stessa mente, ognuno sulla propria corda, ognuno l’essenza stessa della corda, hanno reso anche me parte di quella corda, di quelle note, di quella musica, di quella bellezza.

Concludo con una poesia che mi ha donato l’amica Viviana Meloni, un’anima che sento vicina, nel suo libro intitolato “Veleno” (Albatros editore).
Corda tesa
Ogni spirito dilaniato dalla tensione
ha diritto alla sua pace.
Io in questo divenire lacerante
oso solo il dovere della verità.
