
Buchmesse: Balikwas
C’è una parola nella lingua Tagalog delle Filippine che è intraducibile in italiano. “Balikwas significa qualcosa come: saltare all’improvviso in un’altra situazione e sentirsi sorpreso, cambiare il proprio punto di vista, vedere cose che credevamo di conoscere in modo diverso”. Cambiare prospettiva potrebbe essere una buona parafrasi, ma non è una parola unica, non include la percezione del salto, come invece è insito in questa parola di una lingua che non conosco e che mi è stata regalata dallo scrittore Gianrico Carofiglio.

Me l’ha scritta gentilmente sul mio taccuino, perché non avevo capito come si scrivesse, dopo averla ascoltata pronunciare da lui, che raccontava il senso profondo del suo libro, “Le tre del mattino” (Edizione ET Einaudi), a una platea di italiani e tedeschi interessati alla edizione tradotta in tedesco da Verena von Koskull, “Drei Uhr Morgen” (Folio Varlag).
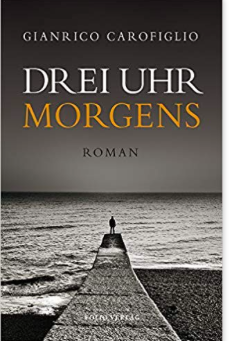
Nel libro, a un certo punto della narrazione, una donna spiega il significato della parola al protagonista della storia, un ragazzo:
“-Fino a due giorni fa io non conoscevo mio padre, – mormoro senza pensarci su.
-Questo è Balikwas.
Poi mi racconta altre cose (…) che lei, io, tutti, siamo entità frammentate: una sequenza di emozioni, inclinazioni, tratti, desideri che ci tirano in direzioni diverse, in modo contraddittorio, e che bisogna dilapidare la gioia, quando ci sorprende, perché è l’unico modo per non sprecarla. (…) Tanto dopo sparisce lo stesso.”
Il romanzo narra l’evoluzione e la trasformazione di un rapporto tra un figlio e un padre, attraverso la voce del figlio, che racconta come ha scoperto chi fosse veramente suo padre durante un viaggio di formazione, non solo metaforico. In realtà la storia non è solo questa, ha a che fare con la malattia, una ‘brutta malattia’, una ‘vergognosa malattia’, come è percepita purtroppo in molti casi l’epilessia. E anche da questo punto di vista il libro aiuta a compiere quel salto che consente di trovarsi dalla parte di chi è epilettico, nella pelle di chi convive con questa malattia.
Carofiglio ha raccontato che uno dei riscontri più belli che ha avuto dopo aver scritto il romanzo è arrivato da una ragazza epilettica: “È venuta da me e mi ha ringraziato dicendomi che, nonostante sua madre l’avesse sempre aiutata, lei percepiva che non aveva mai davvero capito. ‘Quando ho letto il suo libro, l’ho regalato a mia madre. Perché ora lei sa’, mi ha detto. Aver scritto questa storia mi ha dato alcune delle emozioni più forti che abbia mai provato, nel rapporto con le persone che lo hanno letto. E questo vale la pena.” L’autore conversava con Luigi Reitani (professore di Letteratura Tedesca all’Università di Udine e direttore dell’Istituto di Cultura Italiana a Berlino), nella Piazza Italia della fiera, uno spazio dove i lettori tedeschi o italiani potevano incontrare autori italiani tradotti nella lingua madre della Buchmesse.

La possibilità di cambiare completamente la prospettiva sulle cose è il vero dono che ci offre la letteratura e forse l’arte in genere. In questo caso, la storia stessa del romanzo racconta come un figlio si trovi a fare quel salto e a cambiare totalmente prospettiva su suo padre. Avviene una notte, in una città straniera per entrambi, Marsiglia, in un locale Jazz, dove il figlio scopre che suo padre, un matematico, è bravissimo a suonare il pianoforte, a lasciarsi andare all’improvvisazione, prestandosi a sostituire il pianista di un gruppo che i due sono andati ad ascoltare in un locale. La scena del padre che si siede al piano, dell’imbarazzo del figlio che gli ha appena detto ‘vai’, quel tempo dilatato dalle note, prima composte, un po’ abbottonate, e poi via via più aperte, libere, sicure, capaci di consentire all’esecutore di abbandonarsi al suo talento e sbottonarsi, scoprire una parte di sé sconosciuta al figlio, quel momento in cui la musica sembra quasi di sentirla tra le parole, poche, che descrivono una scena di trasformazione, è di una bellezza struggente. E, come tutti i salti, dura un attimo, poi sei già dall’altra parte, non puoi far altro che vedere con nuovi occhi. Tutto: chi sei tu, chi sono gli altri, chi sei in relazione agli altri, ai fatti che accadono.
“All’inizio era circospetto. Capivo poco di musica e nulla di quella musica in particolare, ma avevo l’impressione che suonasse qualche nota in meno, che fosse un po’ contratto, che procedesse per tentativi alla ricerca del punto di sintonia. Alla ricerca del punto di ingresso.
Poi, a poco a poco, i tasti parvero liberarsi, i suoni del piano parvero diventare più pieni e ricchi, e comincio a dialogare con gli altri come qualcuno che entra educatamente in una conversazione già cominciata. (…)
Le sue mani erano agili e veloci: il loro movimento comunicava un senso di essenzialità che era molto bello, come una metafora ben riuscita, un ideale di stile, un modo di essere nel mondo. (…)
E papà suono da solo. Io non lo avrei confessato nemmeno a me stesso, ma ero orgoglioso e fiero di lui, e avrei voluto dire a chi mi stava vicino che il signore alto, magro, dall’aspetto elegante che era seduto al piano e sembrava molto più giovane dei suoi cinquantun anni, era mio padre.”

La scena non è unica nel genere. La musica è spesso un appiglio, una liana che ci aiuta nel salto. Mentre leggevo pensavo a un frammento del film “The Green Book”, di cui ho scritto partendo dalla parola Oltre. C’è un momento in cui il famoso musicista Don Shirley, nero, pianista ed esecutore di brani del repertorio di Jazz ‘colto’ (formato da un percorso di studi classici e di passione per la musica romantica di Chopin), concertista nelle sale di teatri frequentati da bianchi, si siede al pianoforte in un locale di soli neri e trascina nel turbine dell’improvvisazione gli ascoltatori, ma anche se stesso, ritrovando le sue radici e la sua appartenenza a una cultura dalla quale si era estraniato. Anche lui attraversa una trasformazione, cambia punto di vista facendo un salto dal mondo dei bianchi, lui nero, a quello dei neri dell’America anni sessanta, ancora profondamente segregati.

Nel romanzo di Carofiglio la città di Marsiglia è una coprotagonista importante. È l’elemento labirintico e notturno nel quale i due viaggiatori si muovono e si trasformano. Si presta bene perché è una città di mare, dove lo scambio culturale e la possibilità di saltare da una prospettiva all’altra è intrinseca alla natura del luogo. Ma il motivo per cui il racconto si svolge in questa città è anche dovuto al desiderio dell’autore di rendere omaggio a un personaggio realmente esistito, un medico, che ha rivoluzionato il campo di ricerca e di cura dell’epilessia. “Il dott. Gastaut è stato un grande medico e mi sembrava giusto ricordarlo nel parlare di questa malattia”, ha raccontato l’autore. “Oltretutto, pur non avendolo mai incontrato o conosciuto, mi è capitato dopo averlo descritto che alcuni lettori che lo avevano conosciuto e incontrato mi dicessero ‘ma lei ha conosciuto Gastaut’. Non è così. E questo ha a che fare con il rapporto tra autore e lettore, o meglio tra lettore e testo scritto. È un rapporto creativo, qualcosa per cui il lettore mette in gioco il suo mondo, la sua creatività, per tirare fuori altro. Credo che questo sia l’aspetto più importante dell’enorme operazione e conversazione collettiva che è quella di leggere e scrivere libri”.

Mentre ascoltavo queste parole pensavo all’opera di mediazione che si compie scrivendo. Ci si rende tramite, ci si presta a tradurre, a creare le condizioni per cui chi legge possa saltare, possa fare esperienza di Balikwas. È un atto a volte consapevole, a volte meno consapevole, è comunque un’azione che compie anche chi scrive, se il desiderio è quello di comunicare e tradurre qualcosa per qualcun altro. Perché anche rileggendo quello che si è scritto potrebbe capitare di trovarsi dall’altra parte, come se l’atto stesso della scrittura ci abbia permesso di compiere il salto, di arrivare a un punto dal quale le cose appaiono in un’altra prospettiva. Come succede quando si tiene un diario. E lo si rilegge dopo tempo. E si trovano cose che non si pensava ci fossero.
Nell’avventurarmi in questo pensiero, mi è apparsa la strada piena di curve, ostacoli, deviazioni e cambi di rotta, che percorro quando scrivo. Ma anche quella che ho percorso in tutta la mia vita sempre e comunque scrivendone, su diari e taccuini. Ho ripensato alla mia tendenza naturale a saltare da un contesto all’altro, processo che ho vissuto spesso come una fuga, con la connotazione a posteriori di aver fallito in qualcosa. Atre volte, più raramente, lo ho vissuto come una ricerca. Il filo conduttore continua a essere la scrittura, con più o meno consapevolezza. Quando studiavo fisica, imparavo la matematica che serviva a tradurre in formule un determinato fenomeno. Ricordo ancora la sensazione di infatuazione per un’equazione apparentemente semplice, come quella di Dirac, nel periodo in cui arrivai a comprendere come risolverla, cosa significasse, come potesse descrivere la struttura dell’atomo di idrogeno, come potesse contenere concetti tanto lontani quanto possono esserlo quelli della relatività ristretta e del mondo dell’infinitamente piccolo. Dalla teoria degli esami per laurearmi, sono passata alla pratica di una tesi in particelle sperimentali, trascorrendo mesi e mesi di fronte a un linguaggio di programmazione, con il fine ultimo di creare linee capaci di simulare i comportamenti di particelle microscopiche. Scrivevo in quel linguaggio, inseguendo due particelle all’apparenza indistinguibili e cercando tecniche per distinguerle. Sono arrivata ad alienarmi in quel modo di fare ricerca. Dopo la laurea, mi sono ammalata e per curarmi me ne sono allontanata, dalla ricerca, lasciando un dottorato incompiuto.
Nel libro di Carofiglio c’è un rimando a una frase del matematico John Van Neumann: “Se la gente crede che la matematica non sia semplice, è soltanto perché non si rende conto di quanto complicata sia la vita”. Il che è vero, ma solo da una certa età in poi. Quando ero giovanissima studentessa ricordo un amico che aveva un suo detto: “La vita è dura, ma la fisica è peggio”. Eravamo al primo anno di università e allora ci identificavamo con quel detto, scontrandoci con i primi esami di Fisica I, o Fisica II. È stato forse per questo che quando mi sono ammalata, di quello che allora sembrava un esaurimento generico ma oggi sarebbe forse etichettato come una depressione, ho lasciato la fisica. Pensavo che davvero fosse troppo dura per me. Solo dopo molti anni ho capito quanto non fosse la fisica a essere così dura, ma la vita stessa, quanto mi sentissi inadeguata a prescindere, non tanto a fare la fisica, quanto proprio a vivere, a essere chi fossi, senza recitare una parte. In parte, allora, la cura l’ho trovata scrivendo: potevo continuare a definirmi una fisica che si dedicava alla divulgazione. Scrivevo per riviste scientifiche o giornali dalle pagine di scienza, e non facevo altro che tradurre quello che leggevo e provavo a capire in ambiti della scienza anche molto diversi dalla fisica, per raccontarlo, descriverlo, renderlo comprensibile a chi volesse fare il salto e capire cosa avveniva in quel mondo. La divulgazione è stata per me un’altra forma di scrittura, di traduzione, da una lingua difficile a un’altra forse più semplice, se riuscivo a capirla prima di tutto io. Questo esercizio non poteva calzarmi a pennello, se non avessi imparato l’inglese a fondo, se non fossi stata in grado di capire, parlare e leggere, la lingua nella quale vengono pubblicati tutti gli articoli scientifici. E per questo motivo ho saltato un oceano e ho talmente cambiato il punto di vista, la prospettiva sulla mia vita, la mia storia, la mia lingua madre, che ho deciso di imparare a scrivere in inglese. In inglese sentivo di pensare in altro modo, da una nuova prospettiva, più libera forse, più diretta di quella labirintica e involuta nella quale ero cresciuta. In inglese avrei potuto fare la scrittrice, non la divulgatrice o la scrivente. Alla faccia dell’involuzione! Credevo davvero che imparando a scrivere in una lingua non mia, sarei potuta arrivare a scrivere narrativa più liberamente, senza il complesso di non aver fatto studi umanistici, senza qual senso di inadeguatezza che mi caratterizzava da sempre!
Con questo non voglio dire che adesso, di ritorno dalla Buchmesse, mi metterò a imparare il tedesco, per arrivare a leggere e scrivere nella lingua della fiera mondiale dei libri, ma piuttosto che, quando ho trovato il libro di Carofiglio e l’ho finalmente letto, la fiera orami un ricordo, ho ripensato alla mia ricerca nello scrivere, trovando un filo dal quale forse sbrogliare quella matassa ingarbugliata. Come se mi fossi seduta a un piano anche io e mi fossi abbandonata al mio vero talento, quello che solo io conosco e solo io posso coltivare.
Succede così, per me, leggendo e scrivendo, che mi trovi, a volte, in uno stato di gioia, e che ne provi tanta da poterla ‘dilapidare’ (è un’altra espressione che rubo a Carofiglio, l’idea che si possa dilapidare la gioia). Figuriamoci se mi trovo nella fiera dell’editoria più grande del mondo. Oggi è già passata, non sono riuscita a raccontarla in tempo reale. Me ne faccio un cruccio. Avrei voluto riuscirci. E il tentativo di una cronaca a posteriori ha forse poco senso. Ho perso quello di quando ero lì, giravo tra libri, editori, scrittori, scriventi, commercianti, curiosi, lettori, maschere di ogni tipo, e tutto quello che vedevo, che ascoltavo, che risuonava tra le frequenze dei miei neuroni, erano parole, tantissime parole e tra tutte, alcune si accostavano a dare un senso al mio essere lì in quel momento per raccontarle, come le capivo e associavo. La riproduzione del puzzle, con i pezzi che ho in mano adesso, non può che passare attraverso i libri che ho incontrato e che, con il giusto tempo, leggerò, per riconoscere quelle stesse parole e ritrovare i pensieri e le idee che mi hanno stimolato. Questo è quello che mi resta: una fucina di idee, di temi, di pensieri. Alla Buchmesse ci si perde, ci si ritrova, si seguono le fila dei propri interessi, e se ne trovano di nuovi. È un caos ordinato, un fenomeno collettivo fatto di tanti fenomeni singoli. Un insieme di particelle che scontrandosi generano energia e nuove particelle. Ci si arriva con alcune idee, le si scambia, le si condivide, e tutto ciò ne fa emergere di nuove, allargando gli orizzonti di ognuno e stimolando salti, mirati a oltrepassare ognuno i propri limiti, i propri confini. Ed è così che quello che è Balikwas per qualcuno diventa una possibilità di Balikwas per tutti.
