
Contagiati
Da un giorno all’altro, sono andata alla presentazione del nuovo libro di Andrea Mauri, dal titolo “Contagiati” (Ensemble Edizioni), e all’inaugurazione della mostra “Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli – Visioni di Simona Filippini”, al Museo di Roma in Trastevere fino a Febbraio 2020. Così, tra la lettura dei racconti e le Polaroid della fotografa Simona Filippini, ho lasciato che le parole di Andrea contagiassero il mio personale taccuino


Può un accento cambiare il corso di una storia? Come lo snodo di un binario, orientare il pensiero in un senso inaspettato? Un segno su una parola, scambiato di posto, può influenzare la percezione della realtà che osserviamo, trasformando un veleno in medicina?
Non nel senso della medicina omeopatica, ma in quello più mistico della capacità terapeutica della letteratura, sia per chi scrive che per chi legge. Nel senso di cambiare accenti alle parole e trasformare un pensiero sordo in uno capace di aprire gli occhi. O anche un’idea cieca in una visione che ascolta e accoglie ciò che ci sembra estraneo, diverso, respingente, straniero. Chi scrive e chi legge, anche nel modo più inconsapevole, percorre una strada piena di accenti, in silenzio li posiziona, a volte li sposta, e in quell’atto tutto cambia, il senso sommerso può venire a galla e quello che appare in superficie può invece risultare privo di senso. L’incomprensibile si insinua tra i pensieri, li trasforma, li rende più densi e più ricchi.
Mi è successo con il titolo del libro di Mauri. Scelto appositamente per essere uno snodo. La parola Contagiati è scritta senza un accento. Ma la dedica regala un indizio: “A chi ama lasciarsi contagiare dalla vita”.
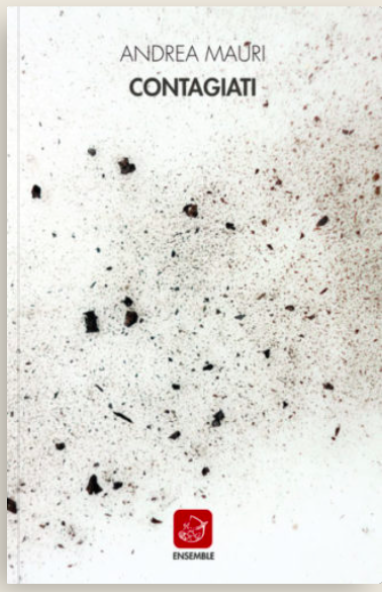
(31 Ottobre 2019-dal mio taccuino contagiato) Ho letto “Contagiati” stanotte. Oscillavo tra i due sensi. Quello dell’imperativo che mi arrivava dalla copertina, contàgiati, mi diceva. E quello del participio passato, contagiàti, come i personaggi dei racconti, accomunati dal filo rosso della malattia, quella derivante da un contagio di qualche tipo.
Qualcosa nel mio inconscio si è smosso.
E ha guidato i passi verso la memoria.
Al risveglio ho cercato Riccardo.
Come non facevo da tempo.
Di cercarlo come se lui fosse ancora qui, ancora vivo, ancora potessi incontrarlo per caso la mattina presto.
Mi sono trovata a camminare lungo Corso Trieste, rivedendo i luoghi che abbiamo attraversato insieme.
Amavamo entrambi la mattina presto.
Ci incontravamo in redazione, nuovi incaricati delle news di Galileo, allora il primo giornale di scienza on line, nato da poco più di un anno, figlio dei primi studenti del Master in Comunicazione della Scienza della Sissa di Trieste.
Postavamo le notizie brevi on line al mattino.
Era bello aver avuto le chiavi della redazione e poter arrivare prima di tutti.
Era bello trovarci in silenzio.
Condividere un tempo di ricerca.
Ognuno nel suo senza darci fastidio.
Non ci davamo fastidio io e Riccardo.
Ci accompagnavamo nell’ascolto reciproco.
E dilapidavamo la gioia quando insieme.
Non era mai abbastanza.
Ma era sempre tanta da poterla dilapidare.
Quando arrivavano gli altri l’incanto spariva.
Diventavamo noi e loro.
E allora uscivamo per una pausa e ritrovavamo la sicurezza in strada.
Perché insicuri lo eravamo entrambi, ma in un modo che ti spinge ad appoggiarti una all’altro senza giudizio, che ti rende capace di vincerla quell’insicurezza, in due, e farne un elemento di forza, una caratteristica che ti fa stare con gli altri senza giudizio.

Ho rivisto Riccardo nello sguardo di Andrea Mauri, seduto a presentare il suo nuovo libro. Come nella canzone di Tenco: “Lontano, lontano”. Osservavo Andrea, al centro dell’attenzione, e percepivo quelle insicurezze, quelle note, quelle pause, quelle titubanze, che rendevano Riccardo così vero, così umano, così perfetto nelle sue imperfezioni. Percepivo la forza delle sue parole scritte. E di quelle che nel presentarsi al pubblico ha scelto di non dire. Non c’era falsa modestia. Non c’era dislivello tra noi in sala e Andrea. Che non era in cattedra. Era solo disposto a stare, lasciandosi raccontare dalle parole che aveva scelto di scrivere. E in ogni parola riusciva a comunicare la forza di una convinzione profonda che veniva da quell’insicurezza di base.

Ho rivisto Riccardo, l’ho sentito vicino, eppure era assente. Mi è mancata la sua gioia di esserci. E ho provato a trovarla in me stessa. Stringendo qualche mano, ascoltando i silenzi dell’amica Ester Arena, la scrittrice che è in me e che è fuori di me, colei che era al mio fianco a sostenere Andrea. Era presente, nonostante la stanchezza di una giornata lavorativa, perché il suo corpo voleva essere assieme al cuore, in ascolto, a testimoniare la fede nella scrittura, nella lettura, nella possibilità di imparare, di fare un passo avanti, di lasciarlo fare a qualcun altro e condividere il percorso.
Stanotte leggevo l’ultimo dei racconti di Andrea, “Se scriverai non ti accadrà nulla”. E ci ho creduto. Pur non credendoci. Sentivo che era il messaggio di Riccardo. Me lo aveva consegnato tanto tempo fa, iscrivendomi a mia insaputa al Master di Trieste. Mi aveva detto: ‘io vado a fare l’esame di ammissione, ci prepariamo insieme, vieni anche tu’. E così era stato. Lui credeva in me. E in questo modo in se stesso. O viceversa, non ha importanza. L’importante era che fossimo insieme. Così siamo andati. E siamo stati ammessi. Di quel periodo ricordo le notti in treno, la gioia di partire, quella di tornare carichi di appunti, di libri da leggere, dei nuovi volti conosciuti, scienziati, giornalisti. Ricordo la nostra prima stanzetta a Trieste, lontano dalla Sissa, trovata senza Airbnb, da uno di quegli affittacamere consigliati dall’amico dell’amico. Prendevamo una doppia e vivevamo assieme per una settimana al mese, i nostri ritmi a tempo senza sforzo, le nostre note intonate a creare armonie ogni volta diverse.
Non sentivo di aver bisogno di spazio con Riccardo.
Credo che anche per lui fosse lo stesso.
Occupavamo lo spazio comune senza sovrapporci.
E questo bastava a consentirci di essere insieme nella nostra personale interezza e incompletezza.

Guardavo Andrea, lo abbracciavo dopo la presentazione del suo libro, e sentivo che Riccardo lo avrebbe abbracciato di più. Lui sarebbe rimasto a bere, a parlare, a finire la serata cantando madrigali o canzoni popolari. Sarebbe stato naturale per lui, e quindi anche per me. Che invece sono tornata a casa. Ascoltando i miei passi e quelli della mia amica. Le sue parole, poche, appoggiate, presenti, capaci di darmi l’àncora in qualsiasi mare.
Arrivata a casa ho cominciato a leggere e, con la sensazione di un salto nel passato, ho letto tra le righe dei racconti di Andrea, cercando la voce di chi non c’è più. E l’ho trovata: “Se scriverai non ti accadrà nulla”. E ci ho creduto dubitandone. Perché Riccardo Tomassetti non è più. Al suo posto ora è il Premio Giornalistico Riccardo Tomassetti . Lui scriveva, eppure gli è accaduto di andarsene da questo mondo. Non è arrivato ai quaranta. Non gli è stato concesso. O forse la sua vita ha deciso di saltare. Di tuffarsi. Di immergersi chissà dove. Salutandolo avevo ancora tanto da dirgli, ancora tanto da chiedergli. Perché in quel tempo non pensi che l’amico possa lasciarti da un momento all’altro. Riccardo non scriveva racconti o romanzi. Da fisico era diventato divulgatore scientifico e si è distinto come uno dei giovani giornalisti più preparati nel campo dell’Hiv/Aids. Scriveva di medicina, di virus, di contagio, di malattia, di cure e di prevenzione. Studiava la ricerca medica, cogliendone le storie, gli obiettivi, i successi, i fallimenti, le imperfezioni. Tra le miriadi di cose che seguiva, è stato curatore del bollettino di Positifs, ha seguito da vicino l’attività dell’associazione Nadir onlus e ha curato l’ufficio stampa e il bollettino dell’Anlaids, la prima associazione italiana nata per fermare la diffusione del virus HIV e dell’AIDS.

“Se scriverai non ti accadrà nulla” mi ha ricordato uno dei racconti più belli di Borges. “Il miracolo segreto”, dalla raccolta “Finzioni”. La tensione creata da Andrea Mauri è la stessa. La capacità di mantenere viva la fede nel momento estremo del trapasso è l’elemento che accomuna i due racconti. E la forza del messaggio, “Se scriverai non ti accadrà nulla”, è dirompente al punto tale che leggendo viene voglia di scrivere, subito, così, senza pensarci troppo, di credere nel potere terapeutico, persino salvifico, della scrittura.
Ne “Il miracolo segreto” c’e un condannato a morte, davanti al plotone dell’esecuzione, che nel tempo fermo, tra lo sparo e l’arrivo del proiettile che lo colpirà, finisce di scrivere a mente l’opera che lo renderà immortale. Il malato in isolamento di Contagiati, ignorato dai medici mentre sa che un virus attaccherà il suo cervello, si ripete le parole della madre, “Se scriverai non ti accadrà nulla”. Intanto guarda il suo quaderno, quello dove ha scritto, lo tiene a mente attraverso lo sguardo, perché la scrittura impressa nella retina sarà l’ultima immagine di sé per gli altri, le parole scritte il ricordo di sé che sopravviverà al suo stesso ricordo.

Con le parole dei racconti di Mauri ancora in circolo, guardavo le foto di Simona Filippini, una donna che conosco da poco tempo ma che mi ha indicato una via, una direzione. Ogni tanto la perdo, la sua guida, ma non perdo più la strada, ormai so. Nei suoi Taccuini Romani, tra le Polaroid di scorci metropolitani, una mi è rimasta impressa sulla retina. Un paesaggio all’imbrunire, un confine di alberi e cielo, al centro un rettangolo bianco, uno schermo di cinema all’aperto, o forse un’apertura di luce, un passaggio, una porta verso. È una di quelle immagini che le guardi e ti dici: “che bello sarebbe stare su quel prato diventato sdraiati su una coperta a guardare un film”. Pensi al cinema, allo schermo. Poi il bianco ti cattura, ti ci trovi dentro, non è più uno schermo è assenza di paesaggio, è uno spazio che sembra delineato per privare il paesaggio di qualcosa. E questa privazione è quello che ti attrae, quello che ti fa venire voglia di guardare, quello che attira lo sguardo, perché vorresti riempire il vuoto o lasciartene riempire, come quando si fa spazio nella mente e un’idea nuova appare.

La mostra è bellissima. Al centro c’è la memoria, il ricordo fissato nel tempo. Attraverso un progetto che unisce le foto di Simona Filippini, miniature di una Roma di strada, particolari di un presente e di una contemporaneità che abbracciano l’ultimo ventennio, ai dipinti di Diego Angeli, scrittore, critico d’arte e artista delle parole vissuto tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. I suoi appunti pittorici raffigurano i paesaggi dell’agro romano o della Sabina, scorci inconsueti, per un’ideale taccuino dove annotare passeggiate romane. Anziché i monumenti di Roma, Angeli ha scelto di privilegiare spazi nascosti, quasi invisibili al turista di allora e a quello di adesso, intravisti percorrendo le vicine campagne romane o le maestose ville storiche.

L’accostamento tra passato e presente sta nella forma e nelle dimensioni delle immagini, simili a cartoline: le Polaroid hanno quasi le stesse dimensioni dei piccoli quadri a olio. I soggetti sono diversi, le pennellate microscopiche dipingono immagini bucoliche della campagna romana del primo novecento, gli scatti fotografici fermano nello spazio tempo di una Polaroid dettagli quasi invisibili, che raccontano storie di chi Roma la vive. Tra i due nasce un dialogo, un passaggio di testimone, dal passato al presente. Ma anche dal presente al passato: nel ricevere il testimone, Simona Filippini lo restituisce scrivendo una bellissima lettera a Diego Angeli, nella quale gli racconta quello che incontra percorrendo la via a lui intitolata. La leggo e mi inchino all’idea, al sentimento, alla costruzione di un ponte, al suo modo di riempire taccuini di parole, non solo di immagini:
“Mio caro Diego,
mancando ormai pochi giorni all’inaugurazione della mostra ho sentito urgente il desiderio di tornare nella via a te dedicata, per raccontartela.
In zona Casal Bruciato, lungo la via Tiburtina, le strade sono intitolate ai giornalisti del passato. Tra questi ci sei tu. Ho voluto percorrerla a piedi partendo da Piazza Riccardo Balsamo Crivelli, discreto poeta, leggo su Wikipedia.
Solo nel tratto iniziale vi sono almeno tre o quattro negozi di parrucchiere, per uomo e per donna, tutti pieni di clienti, è sabato. All’incrocio con via Giuseppe Donati, tuo coevo, costretto all’esilio parigino a causa delle sue inchieste apertamente avverse al regime fascista, vi è un emporio, gestito da una coppia di cinesi, da cui ho visto uscire un bambino che impugnava felice una falce, tra pochi giorni è Halloween. (…)”
Simona continua la passeggiata e la descrive con parole fotografiche, fino alla conclusione: “Cambio marciapiede e noto un giovane uomo che mi sembra stia distribuendo dei volantini, non sono volantini ma banconote da 1 dollaro, parliamo. Ha trent’anni, è arrivato dal Perù con la mamma quando era piccolo. È un artista, cresciuto in compagnia delle grandi tele di Cy Twombly, sua madre prestava servizio presso la casa museo in via Monserrato, dove l’artista aveva vissuto con la moglie Tatiana Franchetti e di cui ci restano le memorabili fotografie del 1966 di Horst P. Horst. Si chiama Walter, nome d’arte Koreaninng, lavora con i ragazzi disabili. Lo invito all’inaugurazione e lo saluto, pochi passi ancora e la tua via finisce su via Tiburtina, quasi all’altezza del Manhattan Caffè. Simona”
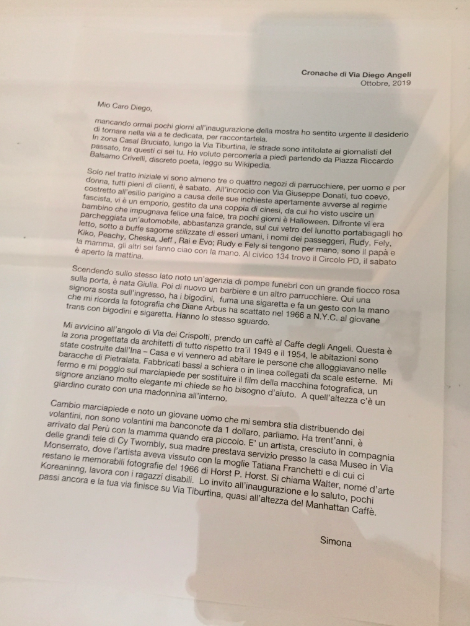
La lettera è il ponte tre due anime, due modi di raffigurare paesaggi che sono due facce della stessa medaglia, quello della natura quasi incontaminata e quello della città abitata dagli esseri umani, che poi sono coloro che osservano e raffigurano, coloro che creano e distruggono, a seconda dei casi.
Partecipando al dialogo tra i quadri, posizionati in due gallerie parallele, con qualche sovrapposizione scelta, ho sentito forte risuonare la parola “Contàgiati”, con l’accento sull’imperativo e non sul participio passato. (31 Ottobre 2019 – dal mio taccuino contagiato) Ero lì, tra i quadri e i volti delle persone che guardavano e mi immergevo nelle foto e nello sguardo di Simona lasciandomi contagiare. Percepivo la storia, il presente nel passato e il passato nel presente. E per un attimo ho pensato che in quel rettangolo bianco mi ci sarei potuta tuffare e dall’altra parte avrei sicuramente incontrato Riccardo. Lui era nelle immagini delle strade romane selezionate dai taccuini di Simona e io ero dall’altra parte, nei paesaggi campestri e bucolici. Come era stato un tempo, quando le nostre esperienze si compensavano e completavano. Allora, quello che io non ero lo trovavo in lui e, ora lo so, anche il viceversa era vero. Non ne ero consapevole perché per me lui era tutto ma ora lo vedo quanto anche io fossi importante per lui, quanto il suo tenere a mente ogni aspetto della mia vita fosse un profondo segno di cura e di amore. Attraverso me lui si curava della campagna, della natura, del verde dei prati, mentre io cercavo in lui la dimestichezza metropolitana, la strada dove perdermi, anche se non sempre avevo gli anticorpi per farlo. Ero una ingenua verace in un bozzolo, che tentava di trasformarsi in una farfalla leggera in volo, mentre lui, con i piedi ben piantati nell’underground romano, sapeva volare libero e sradicato da qualsiasi condizionamento. Con il passare degli anni scopro in me certi suoi tratti, rari germogli da proteggere, cresciuti all’ombra del dolore di averlo perso, di aver perso il suo sguardo sul mondo e sulle nostre vite, capace di contagiare e di lasciarsi contagiare, amando profondamente la vita.

L’amore per la vita è in ognuno dei racconti di Mauri. “Andrea lavora sulla realtà con un registro visionario, la sua fantasia è capace di tirare dentro il lettore anche grazie alla messa in scena di paradossi”. Con queste parole, Stefano Coletta, direttore di Rai 3, ha presentato l’autore nel contesto della libreria romana “Altroquando”. “Nel racconto ‘Ventuno giorni’ c’è una donna che si ammala e deve restare in casa in isolamento per ventuno giorni. Due volte al giorno viene visitata da un medico, un essere con una tuta. E questo incontro vira verso la narrazione di una relazione tra uomo e donna, con grande una capacità di descrivere gli animi femminile e maschile e il loro andare verso l’innamoramento. In questo c’è un tentativo di comunicare un messaggio vitale. C’è un respiro erotico verso la vita. Ognuno di noi può trovare un mezzo salvifico e nel caso di Andrea questo mezzo è la scrittura”.
Il filo conduttore del libro è la malattia, in molte delle sue declinazioni. C’è la paura del contagio, la presenza di un virus, l’isolamento forzato. “Si è imposto questo argomento mentre scrivevo di altro”, ha raccontato Andrea. “Mi capitava di osservare l’atteggiamento di persone che hanno a che fare con la malattia. E ho provato a scriverne, scoprendo su di me cose nuove. Cercavo di focalizzare l’attenzione sul perché la malattia viene rappresentata come un nemico. Mentre invece forse può essere un’alleata, influendo non solo sulla vita di una persona ma anche su quelle degli altri. C’è il tema del diverso che arriva da strade sconosciute e provoca squilibri con il suo carico, scompensi. Mentre scrivevo il mio punto di vista cambiava ed ero spinto a interpretare quello che il diverso ti porta”.
“C’è infatti un grande tema classico, ovvero che la pienezza della vita si possa cogliere davvero solo quando c’è un elemento di disturbo, come la vicinanza con la morte”, ha precisato ancora Stefano Coletti. “L’horror vacui, il vuoto provocato dalla malattia, viene riempito. E la vita diventa uno schermo che si amplia con la nostra consapevolezza. Questo vale ancora di più quando si pensa alla malattia mentale. I ritratti di Andrea sono uno sforzo di combattere la nostra allergia verso il tema della malattia o della morte”.
Che è un po’ come lo schermo bianco, lo squarcio nel paesaggio perfetto, lo spazio aperto che disorienta, incute timore forse, e allo stesso tempo rapisce lo sguardo. Aprendo gli occhi possiamo riempire quel vuoto e, se non ci paralizziamo per la paura, se ci tuffiamo, allora forse ameremo lasciarci contagiare dalla vita.

