
Memoria
Come si può elaborare l’irrimediabile? Come si attraversa l’irremeabile? Come aggrapparsi alla memoria? Sono domande che in forme diverse si pongono e si sono poste le persone sopravvissute alla Shoah, allo sterminio pianificato, lucidamente eseguito, di milioni di ebrei durante la seconda guerra mondiale da parte del regime nazista e fascista. Così come di altri gruppi discriminati da Hitler, i rom, i disabili, gli omosessuali. Coloro che sono ancora vivi, donne e uomini, sopravvissuti ai campi di concentramento, hanno trovato negli occhi delle giovani generazioni una sponda per tramandare e dare un senso alla loro sopravvivenza.

Così in Italia, la Senatrice a vita Liliana Segre, presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, non smette di parlare con le giovanissime generazioni. Il suo messaggio principale è che una volta morto l’ultimo sopravvissuto sarà ancora più difficile preservare la memoria. Come lei anche Edith Bruck, ebrea ungherese sopravvissuta ad Auschwitz, che ha trovato accoglienza in Italia, negli anni di esodo dopo la liberazione dei campi. Divenuta scrittrice, di poesie e narrativa, ha pubblicato il libro “Il pane perduto”, La nave di Teseo, romanzo autobiografico della deportazione e della vita da sopravvissuta allo sterminio. L’ho ascoltata qualche giorno fa raccontare la sua storia, davanti agli studenti di tutta Italia, che partecipavano all’evento organizzato dalla Fondazione Museo della Shoah.

La scrittrice veniva dalla visione, la sera prima, del documentario intitolato “Il respiro si Shlomo” (in onda su Rai 1 il 28 gennaio alle 00:20), la storia di Shlomo Venezia, testimone diretto dell’assassinio sistematico nelle camere a gas di Auschwitz-Birkenau. Sulla visione del film, Edith ha speso poche drammatiche parole. “Ho visto ieri sera il documentario sul papà di Antonio Venezia e ancora oggi tremo dentro. Ho tentato di elaborare. È difficile elaborare”.

Eppure la sua missione è stata e continua a essere quella dell’elaborazione attraverso la scrittura. Il pane perduto fa riferimento alla mattina in cui lei e i suoi famigliari (madre, padre e sei figli), originari di un piccolo villaggio contadino ungherese, vennero prelevati dalla loro poverissima casa, per essere forzatamente condotti al ghetto regionale e, dopo cinque settimane, essere da lì deportati ad Auschwitz. “Gli ultimi due anni, il 42 e il 44 erano stati invivibili. La propaganda nazista fascista ha infettato tutte le persone” ha raccontato Edith agli studenti. “La vita era invivibile, per l’odio, le bestemmie, il fatto che le stesse persone con le quali eravamo cresciuti da un giorno all’altro non ti salutavano. Era un dolore terribile sentirsi offesi dalla stessa nostra lingua ungherese. Ognuno si sentiva potente di poter fare quello che voleva contro gli ebrei. Una vicina di casa, il giorno prima che fossimo deportati, ha regalato la farina alla mia mamma per fare il pane. E lei ne era felice, venivamo dal periodo pasquale in cui non si mangia il pane. Per tutta la notte aveva controllato la lievitazione. Verso le cinque due gendarmi hanno fatto irruzione in casa. Mio padre ha preso la decorazioneche aveva ricevuto per i meriti durante la Prima Guerra Mondiale. Ha fatto vedere questa cosa, pensando potesse chiedere un favore. Ma questo fascista di 25 anni, un ragazzo del paese, cosa ancora più dolorosa, ha buttato per terra la medaglia e l’ha calpestata, dicendo che queste cose non valevano più. Ha poi dato uno schiaffo a mio padre. E lí ho capito che era qualcosa di irrimediabile. Mio padre aveva 49 anni io 12 e mezzo. Da lì a cinque minuti eravamo fuori di casa, prima nella sinagoga del paese e poi nel ghetto. Lì ho visto il primo tedesco. C’è una condanna esplicita nelle parole di Edith, rivolta a tutti gli ungheresi che hanno contribuito allo sterminio degli ebrei. “Dopo la guerra hanno detto che sono stati i tedeschi a portarci via. Ma non è vero”, racconta la scrittrice. “Il primo tedesco l’ho visto nel ghetto. Urlava e bestemmiava. Però quella lingua mi ha fatto meno male della lingua ungherese, la mia lingua natia, la mia lingua madre”.

Nel suo racconto la Bruck parla di cinque luci, ovvero cinque momenti di chiarore persino nell’oscurità più totale, il primo quello in cui un tedesco le ha detto di andare a destra, scendendo dai vagoni di fronte al campo di Auschwitz. La fila di sinistra era quella che andava diretta alle camere a gas. Un altro momento di luce appare dopo la liberazione, quando lei e la sorella, salvate dagli americani e curate dalla denutrizione, sono state avviate a intraprendere il viaggio di ritorno a casa. In quella fase le due sorelle sono state avvicinate da cinque soldati fascisti che chiedevano cibo e aiuto per tornare a casa. Entrambe, scambiandosi un solo sguardo, hanno deciso di dividere i viveri che avevano ricevuto dagli americani con questi cinque soldati e fare una parte del viaggio con loro. “In questo viaggio, con questi cinque soldati, non sapendo nulla, abbiamo diviso tutto il cibo che gli americani ci avevano dato. E avevamo una sensazione molto molto grande, importante, quella di dividere il cibo con i nostri assassini”. Il racconto di Edith Bruck è intriso di spiritualità. E del significato profondo della parola perdono quando si incarna nel valorizzare la vita a prescindere.

Anche Sami Modiano, ebreo polacco sopravvissuto a Birkenau, non si stanca di raccontare l’orrore, fin quando ci saranno giovanissimi e giovanissime ad ascoltarlo, perché questo orrore non debbano viverlo più, nessuno di loro, o di chiunque verrà dopo di loro. Lo ha fatto di fronte agli studenti in questo giorno della Memoria 2023, commuovendosi fino alle lacrime.

In questi giorni ho ascoltato la storia dei cinque protagonisti del documentario intitolato “Gli ultimi giorni”, documentario statunitense del 1998, visibile su Netflix. Le voci principali sono quelle di cinque ebrei ungheresi (Tom Lantos, unico sopravvissuto alla Shoah eletto al Congresso degli Stati Uniti d’America e morto nel 2008; Bill Basch, anche lui morto nel 2008; Dario Gabbai, deceduto nel 2020; Alice Lok Cahana, pittrice deceduta nel 2017; Renèe Firestone e Irene Zisblatt ancora in vita). Oltre a loro, la voce di un medico delle SS di Auschwitz, e di alcuni soldati americani entrati per primi a liberare i campi. Ogni storia è diversa, ma il messaggio è quello di coloro che hanno perso tutto e, soli al mondo, si domandano perché io? Trovando risposta nel valore della vita che verrà, nei propri figli, nei propri nipoti e in coloro che sapranno raccogliere la loro memoria dell’orrore irremeabile.

La memoria ci riguarda ogni giorno, il 27 gennaio ce lo ricorda, diventando la punta dell’iceberg di un processo di elaborazione che non può cessare. Se così fosse, basterebbe poco perché le voci di chi minimizza, di chi nega, di chi sommerge, prendessero il sopravvento.
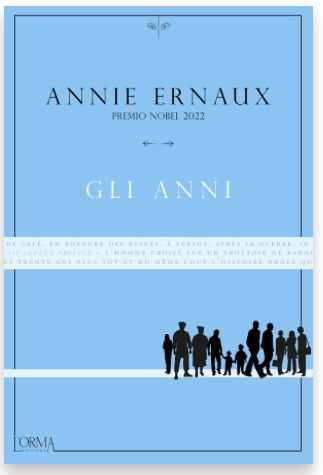
Mi ha accompagnato, in questa settimana che preclude al giorno della memoria, la voce di Annie Ernaux, nel suo “Gli anni” L’orma Editore, un libro sul senso della memoria appunto. L’incipit è fulminante: “Tutte le immagini scompariranno. (…) le immagini reali o immaginarie, quelle che persistono anche nel sonno. le immagini di un momento bagnate di una luce che è soltanto loro. Svaniranno tutte in un colpo solo come sono svanite a milioni le immagini che erano dietro la fronte dei nonni morti da quasi mezzo secolo, dei genitori morti anch’essi. Immagini in cui comparivamo anche noi, bambine, tra gli altri esseri scomparsi prima ancora che nascessimo, nella stessa maniera in cui ricordiamo i nostri figli piccoli assieme ai loro nonni già morti, ai nostri compagni di scuola. E così un giorno saremo nei ricordi dei figli in mezzo ai nipoti e a persone che non sono ancora nate. Come il desiderio sessuale, la memoria non si ferma mai. Appaia i morti ai vivi, gli esseri reali a quelli immaginari, il sogno alla storia.”

Ernaux scrive come dalla cima di una cascata, l’acqua scrosciante la storia che avanza, gli schizzi che le bagnano il volto, fermati dalle sue parole su carta, immagini brillanti, vivide, drammatiche, tragiche, gioiose, rassegnate, ineluttabili, immagini singole a rappresentare un’umanità intera, la goccia che diventa il mare e affonda nel senso dell’inconscio collettivo che tutti ci attraversa. Il suo libro mi ha tenuta sul ciglio di un burrone. Da quelle gocce salvate all’oblio il passo è breve, eppure tutto il resto appare, anche il non detto si salva. Una goccia ricorrente è quella dei pranzi della domenica. La pausa musicale nella quale tutta l’orchestra si ferma e si sta tra il passato e il futuro. Sono pranzi in cui i discorsi cambiano negli anni, per rimanere in fondo gli stessi “Prima o poi si tornava a parlare della guerra.Ricordavano l’esodo, i bombardamenti, i razionamenti post bellici, la moda degli zazous, i pantaloni da golf. Era il romanzo delle nostre nascite e della nostra prima infanzia, lo ascoltavamo presi da una nostalgia indefinibile. (…) Ma nel tono delle voci era percepibile una forma di distanza. Se n;’era andato qualcosa. Erano morti i nonni che avevano conosciuto due guerre, i bambini erano cresciuti, la ricostruzione delle città era terminata, c’era il progresso e il mobilio comprato a rate”. E così anche qui, nello scritto di Ernaux si coglie l’importanza del racconto in prima persona. Della testimonianza diretta. Fino a quando i testimoni diretti sono vivi e raccontano, qualcuno prende il testimone e non permette che vada a fondo.

Dall’Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano, luogo votato a custodire e tramandare le memorie dei singoli, perché diventino memorie collettive, leggo una delle tante testimonianze sottratte all’oblio, proveniente dal diario di Arnaldo Grue. In Abruzzo, ad Atri, sul finire degli anni Settanta Arnaldo trascorre un periodo di ferie estive nel suo paese natale. E qui viene affiancato da un uomo anziano, padre di un suo ex compagno di scuola. L’uomo gli domanda se sia proprio lui il figlio di quel tale A. Grue deceduto da qualche tempo. E poi gli racconta una storia riguardante suo padre, nel periodo dell’occupazione nazista, verso la fine del 1943. Le parole dell’uomo sono riportate nel diario di Arnaldo: “Durante l’ultima guerra nel periodo d’occupazione tedesca, ero il custode del circolo cittadino. Conoscevo molto bene tuo padre, che mi aveva aiutato molte volte in momenti di difficoltà. Il circolo era stato requisito dagli ufficiali tedeschi, che vi passavano il loro tempo libero, giocando a carte ed a biliardo. L’apertura e la chiusura dipendevano dalle esigenze dei singoli ufficiali; molte volte giocavano tutta la notte. Tuo padre frequentava la sala da biliardo di notte, quando non c’era più nessuno. A casa sua forse, credevano che si recasse a qualche appuntamento galante, e questo credo sia stato l’origine di molti dissapori in famiglia, invece veniva di notte al circolo cittadino per giocare a biliardo con alcuni ufficiali tedeschi”. Alla domanda di Arnaldo su cosa si giocassero il padre e gli ufficiali, l’uomo risponde. “Si giocavano un ebreo a partita: se vinceva tuo padre, allora l’ebreo lo portava via lui, altrimenti rimaneva ai tedeschi. (…)” La contropartita? “Un diamante a partita. Un diamante contro un ebreo. Metteva in palio due orecchini con diamanti azzurri, grossi come noci. Posso assicurarti che di partite ne giocò tante, ma non fu mai sconfitto. Gli ufficiali tedeschi erano talmente soddisfatti di perdere giocando contro di lui, che talvolta gli cedevano alcuni ebrei in soprannumero.” Quegli orecchini, gioiello di famiglia, Arnaldo li aveva visti molte volte nel dopoguerra, in casa, senza immaginare che fossero stati, un tempo, un pegno ipotetico in cambio della libertà e della sopravvivenza di molti esseri umani.
